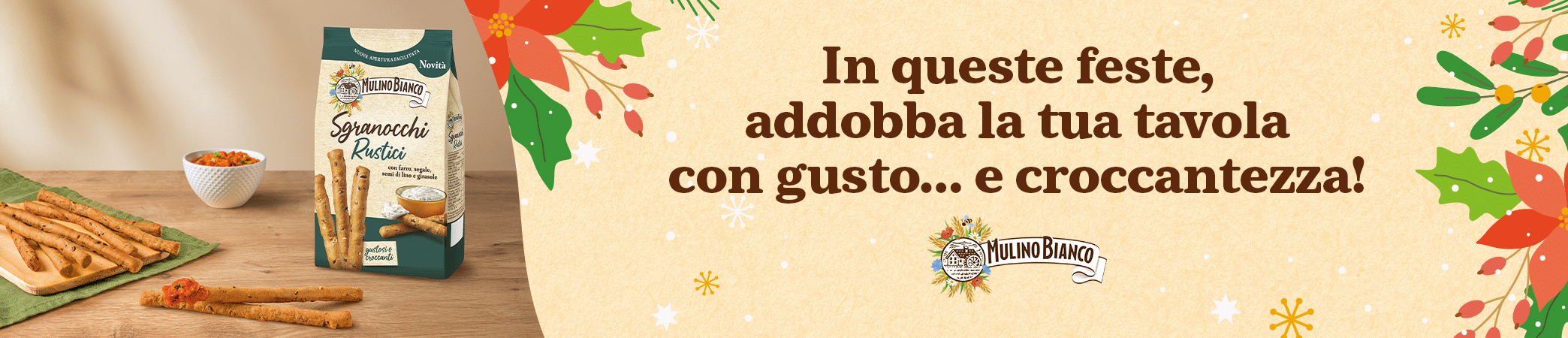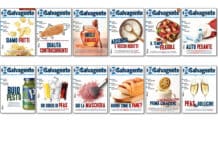Nel numero di marzo 2025 pubblichiamo i risultati del nostro test su 14 marchi di miele: spesso invecchiato e con sostanze nemiche delle api, come i famigerati neonicotinoidi, il millefiori non è in buona salute
Invecchiato e contaminato da sostanze nemiche delle api, il miele millefiori che abbiamo portato in laboratorio non esce bene dal nostro test, i cui risultati sono pubblicati nel numero di marzo 2025 del Salvagente. In 9 dei 14 marchi analizzati ha lasciato traccia l’acetamiprid, un pesticida neonicotinoide, uno dei famigerati killer delle api. E non è l’unica presenza che rende amaro il nostro miele: in alcuni vasetti è spuntato il thiacloprid, sostanza della stessa famiglia dell’acetamiprid, vietato dal 2021 e lo spirotetramat, accusato di interferire con il sistema ormonale umano, che verrà bandito definitivamente il prossimo ottobre.
Vuoi leggere tutti i nomi e i risultati del test del Salvagente? Clicca sul pulsante verde qui in basso e acquista la tua copia del giornale
Naturalmente gli apicoltori sono, insieme agli insetti impollinatori, le prime vittime dei pesticidi e della loro persistenza ambientale. Parliamo infatti di sostanze sgradite che finiscono nel vasetto non già perché impiegate da chi confeziona miele ma perché essendo così utilizzati dagli agricoltori che difficilmente le api riescono a evitarli. Per di più parliamo di molecole, come appunto il thiacloprid, capaci di persistere nei terreni e nelle acque tanto da continuare a contaminare piante e fiori anche dopo molti anni da quando sono stati messi al bando. C’è poi una domanda preoccupante che emerge analizzando i nostri dati: perché una sostanza capace di provocare la morte delle api, l’acetamiprid, è così presente in uno dei prodotti di quegli alveari minacciati proprio dal pesticida?
La presenza dell’acetamiprid è sintomo che questo insetticida è stato “spruzzato” durante la fioritura anche se, come ci spiegano gli esperti, nelle regole di ingaggio dell’acetamiprid c’è proprio il divieto di utilizzarlo durante il germogliamento proprio per evitare di attaccare le api. È evidente che ritrovarlo così diffusamente nei lotti analizzati significa che i coltivatori sempre più spesso non rispettano le regole d’utilizzo di questo pesticida.
Un altro elemento critico emerso dalle nostre analisi è la freschezza del miele e l’integrità delle sue qualità organolettiche che possono essere valutate a partire dalla concentrazione di un composto, l’idrossimetilfurfurale, in sigla Hmf. Questa sostanza si crea naturalmente per effetto della degradazione della componente zuccherina: più passa il tempo e più questo indicatore cresce. Tuttavia il processo di “invecchiamento” accelera se il miele viene conservato male ovvero vicino a fonti di luce o di calore.
Come è stato stoccato nei magazzini prima ed esposto sugli scaffali dei supermercati poi? È la domanda che i produttori rivolgono polemicamente di fronte a dati dell’Hmf molto alti. Se vogliamo la stessa che gli imbottigliatori di olio extravergine avanzano di fronte alla presenza di prodotti difettati per scaricarsi da qualsiasi responsabilità.
A differenza dell’extravergine però il miele ha un Termine minimo di conservazione più lungo (è deciso dal confezionatore ed è di almeno 18 mesi ma è facile trovare prodotti a “scadenza” dopo tre anni) e sicuramente rispetto all’oro verde, il nettare giallo ha una rotazione a scaffale minore. E dunque risultano ancora più decisive le condizioni di conservazione per evitare colpi di calore o prolungate esposizioni alla luce che possono far invecchiare il prodotto più velocemente.
Scorrendo le tabelle pubblicate nel numero di marzo 2025 tuttavia si possono trovare prodotti che superano tutte le prove a pieni voti e non parliamo solo di mieli biologici. Resta però un punto di fondo che i nostri risultati non fanno che confermare: se le api sono le sentinelle dello stato di salute della natura circostante e della filiera agro-alimentare, di certo bisogna invertire la rotta per evitare un punto di non ritorno. L’inquinamento ambientale da pesticidi, anche in Italia, è ormai una emergenza per l’umanità.
Tre diverse analisi in due laboratori
In due laboratori abbiamo condotto le analisi sui 14 campioni di miele millefiori (12 convenzionali e 2 biologici) per valutare la presenza di pesticidi, di acqua e la freschezza.
Provenienza
Non ha influito nel giudizio finale: 7 campioni sono di origine italiana; miele italiano lo ritroviamo miscelato in altri 4 marchi; i restanti prodotti provengono da paesi stranieri, Ue ed extra Ue. In 2 casi c’è miele anche tropicale.
Pesticidi
Naturalmente gli apicoltori non usano trattamenti fitosanitari e la presenza dei residui è attribuibile all’inquinamento ambientale. Tutti i residui riscontrati sono ampiamente al di sotto al limite di legge. Quando i principi attivi non hanno superato il Loq, il limite di quantificazione analitica (0,01 mg/kg), abbiamo riportato solo il numero di “tracce”. La sostanza più ricorrente sopra al Loq (ma anche al di sotto) è l’acetamiprid, l’insetticida neonicotinoide, accusato della moria di api e sospettato di essere interferente endocrino per l’uomo. Meno ricorrente è lo spirotetramat (rilevato in due campioni), insetticida, nocivo per la riproduzione e per il feto tanto da essere stato vietato: l’uso è consentito fino al 30 ottobre 2025. A basse concentrazioni ma sopra il Loq abbiamo rilevato anche il boscalid (in un millefiori), fungicida, sospettato di essere un interferente endocrino. Tra le tracce abbiamo riportato il nome delle molecole neonicotinoidi: oltre all’acetamiprid, ancora autorizzato, abbiamo rilevato anche il thiacloprid (in tre marchi della grande distribuzione), vietato dal febbraio 2021.
Umidità
Non esiste un vero e proprio limite di legge ma un valore guida che stabilisce la presenza di acqua al di sotto del 20% del prodotto finito. Di fatto maggiore è questo valore e minore risulterà la presenza di miele nelle confezioni. I valori rilevati in laboratorio sono tutti al di sotto del 20% e non differiscono di tanto tra loro.
Freschezza
Con questo termine abbiamo voluto rappresentare i risultati dell’idrossimetilfurfurale, l’Hmf, che si forma naturalmente nel miele dalla degradazione degli zuccheri ma che tende ad aumentare con il calore o con l’invecchiamento del prodotto. Esistono due limiti di legge per questa sostanza: 40 mg/kg e 80 mg/kg per i mieli o le miscele di origine tropicale, sottoposte per loro natura a temperature più alte (nel nostro panel due campioni: Mielizia e Ambrosoli). I risultati segnalano una grande varietà: in un caso, Apicoltura Casentinese, il risultato supera il consentito.
Dall’azienda precisano: “Per quanto riguarda i parametri di Hmf e Diastasi noi possiamo garantire il rispetto della legislazione per la merce presente in stock nei nostri magazzini, il mantenimento del miele in luoghi freschi e asciutti, lontano da fonti dirette di calore e dai raggi solari, è il presupposto per il migliore mantenimento nel tempo. Ecco perché anche la distribuzione deve impegnarsi nel garantire questi presupposti. Nella fattispecie il contro campione del lotto oggetto delle vostre analisi, risulta dai nostri controlli conforme alla legislazione in vigore in quanto il valore dell’Hmf ci risulta essere inferiore a 20 mg/kg, ipotizziamo quindi che il prodotto prelevato negli scaffali, possa aver subito stress termici, anche di piccola entità ma prolungati, non a noi imputabili”.
Come abbiamo dato i giudizi
La presenza anche in tracce (sotto lo 0,01 mg/kg) dell’acetamiprid pregiudica il giudizio a Mediocre. La presenza anche in tracce di thiacloprid, sostanza vietata, pregiudica il giudizio a Scarso. La presenza di Hmf sopra i 30 mg/kg (per i mieli non tropicali) penalizza fortemente il voto finale.
Limiti di legge:
Hmf 40 mg/kg e 80 mg/kg per i mieli di origine tropicale;
Umidità: inferiore a 20%;
Acetamiprid 0,05 mg/kg
Spirotetramat 0,5 mg/kg
Boscalid 0,15
Vuoi leggere tutti i nomi e i risultati del test del Salvagente? Clicca sul pulsante verde qui in basso e acquista la tua copia del giornale