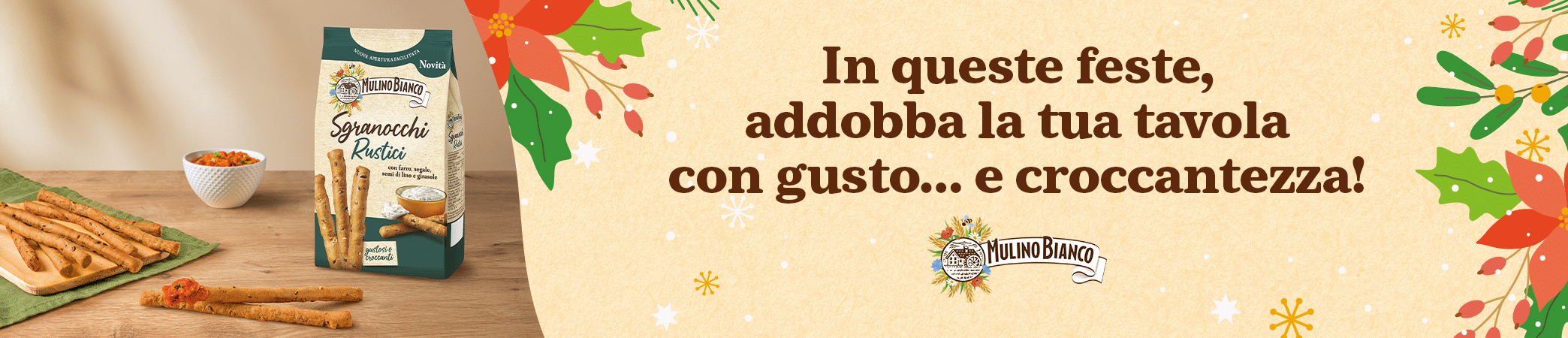Da giorni il giornalista Dom Phillips e l’avvocato Bruno Araújo Pereira sono scomparsi in Amazzonia. Il Salvagente ha incontrato un amico e un ex collega di Pereira, costretto a espatriare dal Brasile per le minacce di morte ricevute nel suo ruolo pubblico di difensore di ambiente e indigeni. E ci ha raccontato come sia forte l’ipotesi che i due siano caduti in un’imboscata.
Sono giorni di angoscia per chi sta seguendo in tutto il mondo la sorte di Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira, scomparsi in Amazzonia. Il primo, giornalista britannico e collaboratore di testate con the Guardian, New York Times e Washington Post, il secondo avvocato, specializzato nella difesa delle popolazioni indigene. Si erano imbarcati, domenica mattina presto, per un breve viaggio sul fiume. Erano stati già minacciati da uomini armati e Pereira aveva ricevuto in precedenza una minaccia scritta. Mercoledì, la polizia nella regione di Javari, nello stato di Amazonas, ha annunciato di aver arrestato un sospetto e di quattro testimoni in relazione alla scomparsa. Phillips ha viaggiato molto nella regione amazzonica per riferire sulla crisi che affligge le foreste pluviali del Brasile e le sue comunità indigene e stava lavorando a un libro sulla conservazione l’ambiente. Pereira è un ex funzionario del governo che ha trascorso anni a lavorare per proteggere le tribù isolate.
Entrambi mestieri molto pericolosi in un paese come il Brasile che ha visto intensificarsi la deforestazione, appoggiata apertamente dal governo Bolsonaro, e che sta vivendo una “guerra a bassa intensità” contro chi si ostina a difendere le terre e le comunità indigene che ci abitano.
A definirla così è Ricardo Rao, collega e amico di Pereira, ex funzionario del Funai, la Fondazione indigena brasiliana, che nello stato brasiliano del Maranhão si è occupato per 9 anni della protezione di ambiente e popolazioni indigene. Il Salvagente lo ha incontrato a Roma, dove si è rifugiato dopo essere fuggito dal Brasile per approdare prima in Norvegia e poi nel nostro paese per non perdere la vita, come era successo a molti dei suoi colleghi e amici.
Rao, non le sembra esagerato definirla “guerra” quella in atto in Amazzonia?
E come dovrei chiamarla? Ci sono i morti, e purtroppo tanti anche tra i miei amici. Ci sono rifugiati come me. Ci sono le invasioni delle terre indigene… È una guerra asimmetrica, contro un popolo con poche difese, che sta perdendo anche quelle su cui poteva contare, grazie all’appoggio del governo Bolsonaro ai taglialegna, ai cercatori d’oro e a tutti coloro che voglio depredare l’Amazzonia e i suoi popoli.
Andiamo con ordine, cosa faceva in Brasile prima di dover espatriare?
Nel 2010 sono entrato per concorso pubblico al Funai, l’organo dello stato che fa parte del ministero della Giustizia e della sicurezza pubblica. Il mio ruolo come quello di Bruno Araújo Pereira, era quello non solo di difendere l’ambiente ma anche i popoli indigeni. Inutile chiarire che per proteggere la vita dei nativi uno degli obiettivi è salvaguardare le foreste che sono nelle loro terre. Facevamo un lavoro pericoloso perché ci sono molti invasori, molti biopirati.
Tu hai fatto questo lavoro fino al 2019, come è cambiata in quei 10 anni l’attività dei biopirati?
Quando è iniziato il governo Bolsonaro il nostro lavoro è diventato più pericoloso. Non che non lo fosse anche prima ma potevamo contare sull’aiuto istituzionale. Dopo l’insediamento di Bolsonaro gli stessi criminali che dovevamo combattere avevano improvvisamente accumulato più potere e accordi con l’esecutivo.
Cosa facevate in concreto nel vostro ruolo pubblico?
Una lotta senza quartiere alle invasioni di terre indigene e alle attività illegali che lì bande ben organizzate svolgevano. Abbiamo sequestrato armi, camion motociclette, soprattutto bulldozer, i mezzi più devastanti per le foreste. La legge ci autorizzava a bruciarle dopo averle confiscate, dato che trasferirle sarebbe costato troppo al governo brasiliano.
Indubbiamente un compito pericoloso, che dovevate svolgere armati…
Avevamo studiato una strategia per minimizzare il rischio. Quello che succedeva era che qualche indigeno ci segnalava il luogo dell’invasione, il numero di lavoratori che lo occupavano i loro mezzi. E noi pianificavamo l’azione – ripeto nel pieno rispetto della legge – cercando di essere sempre in numero sufficiente per evitare una reazione armata da parte loro. Li arrestavamo e confiscavamo i loro mezzi in questo modo. Purtroppo in almeno un paio di occasioni le cose non sono andate così lisce e ci sono state sparatorie, ma non ho mai perso nessuno dei miei uomini.
Perché nel 2019 ha deciso di lasciare il paese?
Già nel giugno 2019 un distaccamento dell’Intelligence della difesa, la Abin, mi aveva cercato nella sede del Funai, un segnale che non c’era mai stato. Subito dopo è stato aperto un procedimento amministrativo contro di me con accuse false.
Quali accuse?
Di aver minacciato un funzionario con il quale io avevo avuto una discussione perché lo ritenevo corrotto e aveva sabotato una nostra missione.
Lei cosa fece?
Ignorai completamente il procedimento che sapevo essere stato montato ad arte e continuai il mio lavoro. In quel periodo sequestrai una moto a un gangster e mi vidi arrivare di fronte il subcomandante del battaglione della polizia militare, un uomo che gestiva centinaia di uomini: voleva che restituissi la moto al criminale.
Lei non obbedì…
Non solo mi rifiutai ma la bruciai per impedire che la portassero via in altro modo. A quel punto un agente di Polizia militare venne nel mio ufficio, mi puntò una pistola alla testa e mi disse: cambia o muori. In quegli stessi giorni fu ucciso il mio amico Paulo Paulino Guajajara, da taglialegna illegali in un’imboscata all’interno dell’Araribóia nel Maranhão. E decisi di fuggire.
Ed è approdato in Norvegia. Come mai proprio lì?
Ho chiesto asilo lì perché in Norvegia ci sono popoli tribali come i lapponi con cui già avevo contatti. Ho chiamato uno dei leader che conoscevo e lui mi ha detto: tu vieni subito e noi ti aiuteremo nella richiesta di asilo. Poi la Norvegia ha stabilito che, avendo io anche un passaporto italiano non potevo chiedere asilo lì ma potevo spostarmi in Italia.
Ricardo, cosa sa e cosa pensa della scomparsa di Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira?
Ho una buona idea di quello è accaduto. Non siamo ingenui, conosciamo questo lavoro e Bruno e Dom sono morti, questo purtroppo è sicuro.
Noi ci auguriamo che siano ancora vivi ma quel che è sicuro è che il governo di Bolsonaro non sembra si sia molto preoccupato di cercarli come racconta the Guardian.
Non mi stupisce di certo e non dovrebbe stupire nessuno che il governo Bolsonaro non abbia interesse a cercare Bruno e Dom.
Chi li avrebbe uccisi?
Da quello che mi risulta un gruppo di pescatori illegali che erano vicini alla terra indigena in cui Bruno lavorava, Bruno è caduto in un’imboscata, era stato invitato a una riunione e lui con la buonafede ci è andato. Bruno era un uomo buono, lavorava molto con gli indigeni che sono venuti a contatto con i bianchi solo da poco, persone buone, senza malizia e a forza di lavorare con loro si dimentica che ci sono altre persone meno buone, molto più maliziose.
Lei parla di pescatori di frodo, ma sulla stampa sono stati accusati i cercatori d’oro.
In quella regione c’è molto pirarucu, come una piccola balena di 3 metri e pesa mezza tonnellata. Molti compratori di Manaus pagano molti soldi per questo tipo di pesca. Il grosso di questi pesci vivono proprio nel territorio indigeno perché gli indigeni ne fanno una pesca sostenibile. Ecco perché questi pescatori di frodo invadono le terre degli indigeni. Certo c’è la possibilità anche che gli assassini siano stati pagati da cercatori d’oro o perfino dai trafficanti di droga. Quella regione, infatti, è lungo la tratta dei trafficanti di cocaina che arriva dalla Colombia. E anche loro attraversano il territorio indigeno.
Da pochi mesi lei è arrivato a Roma. Cosa fa qui?
Vivo in un palazzo occupato grazie all’aiuto del “Comitê Popular de Lutas Itália” antico Comitato italiano Lula livre. Sto lottando con la burocrazia per ottenere la carta di identità e poi cercare un lavoro. Ma le mie giornate sono impegnate in quello che ora è il mio obiettivo: presentare una denuncia alla magistratura italiana per denunciare Bolsonaro per genocidio causato dal Covid. Con l’aiuto di avvocati brasiliani e italiani, sto identificando le vittime italiane di Covid perché la magistratura italiana aprano un’inchiesta sulla morte di molti, molti italiani. Un altro delle molte responsabilità che mi auguro Bolsonaro paghi.