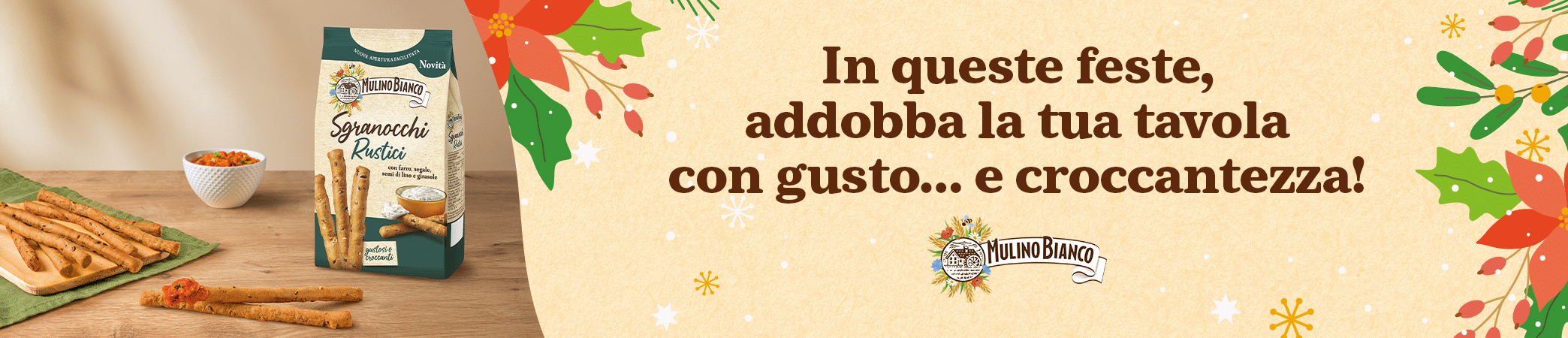Dove vanno gli abiti usati quando li doniamo o li portiamo nei cassonetti adibiti alla raccolta? La domanda è lecita – tanto più in periodi di cambio di stagione come questi – e la sfiducia in Italia si sta diffondendo rapidamente dopo inchieste giornalistiche e provvedimenti della magistratura su episodi di malcostume e criminalità.
Dono, butto o riciclo?
Così molte famiglie non sanno che fare dei capi che non utilizzano più. E finiscono spesso per gettarli tra i rifiuti non differenziabili. Dato che in alcune città – una fra tutte la Capitale di questo paese – non ci sono neppure contenitori adatti alla raccolta.
Eppure maglioni, pantaloni, cappotti e magliette che non usiamo più, se affidati nelle mani giuste prendono varie strade, ma gli obiettivi dovrebbero essere sempre virtuosi ed etici, e molto spesso lo sono.
Gli indumenti vengono raccolti per poi essere donati per le emergenze e i bisogni immediati o venduti per ricavare risorse necessarie a creare posti di lavoro e a finanziare altri progetti sociali. Il meccanismo, semplificandolo molto, è questo.
I numeri sono esorbitanti, sia quelli dei volumi di indumenti raccolti, sia quelli relativi al giro di soldi. Questo, ovviamente, quando le cose funzionano in modo lecito.
Cassonetti della camorra
Ma non sempre va così. Negli ultimi anni, come in molti ricordano, alcune inchieste giornalistiche e giudiziarie hanno fatto emergere situazioni illecite; la più recente, pubblicata da l’Espresso, individua in Tesmapri, colosso della commercializzazione degli abiti usati, un comportamento illecito. Va detto che Edoardo Amerini, presidente e proprietario al 50% dell’azienda, avrebbe già sporto querela a giornale e giornalista.
Tuttavia, in attesa che la giustizia chiarisca la vicenda, chi opera nel settore ci tiene a ribadire l’importanza e gli obiettivi sociali ed etici del mercato mondiale degli abiti usati. Amerini compreso. E, se è vero, come sottolineano da Humana People to People – l’organizzazione di cooperazione internazionale che, tra le sue attività, si occupa anche della raccolta degli abiti usati per finanziare le sue opere nei paesi poveri– che è fondamentale “eliminare le mele marce”, è altrettanto vero che su una cosa è importante fare subito chiarezza: distinguere tra ciò che viene donato in senso stretto e ciò che viene conferito nei cosiddetti “cassonetti gialli”.
La legge sugli sprechi alimentari del 30 agosto 2016 lo spiega bene all’articolo 14, dove tratta degli indumenti usati. “Possono essere considerate donazioni solo quegli oggetti che vengono conferiti direttamente dai privati nelle sedi operative dei soggetti donatori; tutto il resto è da trattarsi alla stregua della raccolta differenziata dei rifiuti”, riferisce Carmine Guanci di Vesti solidale, la cooperativa sociale che è membro, insieme ad altre cinque, della rete Riuse (Raccolta indumenti solidale ed etica) che collabora con la Caritas ambrosiana. Dunque, non tutti i capi di cui ci si disfa costituiscono realmente delle donazioni: lo sono effettivamente solo quelli portati direttamente a soggetti caritatevoli come le parrocchie (ma non solo) che raccolgono e donano a persone bisognose.
Ma la raccolta presenta numeri straordinari che travalicano i bisogni del territorio: “Se contiamo che un kg di abiti corrisponde a circa tre capi, le 8mila tonnellate all’anno che noi raccogliamo nella diocesi di Milano equivalgono a 24 milioni di capi”, precisa Guanci.
Questa distinzione – tra donazione e ‘rifiuto’ -, se compresa, secondo lo stesso Amerini, che è anche presidente del Consorzio Conau (Consorzio abiti usati), mostra come si possano creare fraintendimenti nell’opinione pubblica: “È un vero ‘inghippo’ a causa del quale l’idea diffusa è che se qualcuno fa profitto con gli abiti usati non è una persona ‘pulita’. Ma non si pensa che, nel momento in cui un’azienda come la mia acquista materiale dalle cooperative sociali di tipo B che raccolgono, ad esempio, per Caritas, questi soggetti vengono pagati (si parla ogni anno di milioni di euro) e i soldi vengono reinvestiti nel sociale e sul territorio, appunto”.
Una filiera complicata
Stesso ragionamento anche per le realtà più piccole: la possibilità di vendere garantisce anche la copertura dei costi delle attività, altrimenti non sostenibili.
Dunque, l’eccedenza della raccolta rispetto ai bisogni territoriali e il fatto che nei cassonetti finiscano spesso indumenti malconci e sporchi che non possono essere re-indossati, giustifica questo doppio binario nell’utilizzo degli abiti usati. L’eccedenza richiede grandi strutture per lo stoccaggio, il cattivo stato in cui si trovano i capi rende necessaria un’ulteriore selezione e un processo di sterilizzazione; infine, quando gli indumenti sono davvero ridotti male, subentrano altri soggetti che li acquistano per utilizzarne le fibre e i filati. In tutti questi casi, l’obiettivo etico resta, in un certo qual modo, perché, se il privato svuotasse il suo sacco di indumenti usati in un contenitore per la raccolta indifferenziata, non permetterebbe il riutilizzo e/o il riciclo di quei capi.
“Le nostre percentuali sono in linea con quelle europee: il 70% degli indumenti usati viene riutilizzato, il 25% si trasforma in fibra e filati, il 5% finisce al termovalorizzatore diventando energia”, riferisce Guanci.
5.500 piscine olimpioniche di “cenci”
I numeri dei rifiuti tessili sono esorbitanti: si stima che ogni cittadino europeo consumi oltre 13 kg di indumenti all’anno; quindi 5,7 milioni di tonnellate diventano rifiuto: una quantità che può essere contenuta in 5.500 piscine olimpioniche, come spiega la rete europea Rreuse sulla base di uno studio svolto della Commissione europea. Tuttavia, ancora la raccolta di questi indumenti non viene del tutto differenziata e finisce quindi in discarica o nell’inceneritore. In ogni caso, nel 2014, il commercio di abiti usati ha riguardato 4,2 tonnellate di pezzi, per un valore di 4,4 miliardi di dollari.
Humana, dal canto suo, è caratterizzata da un altro tipo di organizzazione: i cassonetti degli abiti vengono svuotati ogni settimana, gli indumenti vengono portati nelle sei città dove hanno sede gli impianti di proprietà dell’organizzazione autorizzati allo stoccaggio, alle selezione e alla sterilizzazione. Poi prendono due strade: “In parte vanno in Africa donati alle nostre consorelle, che smistano nuovamente gli abiti, a loro volta donano in caso di emergenze o altrimenti rivendono. Il resto viene venduto al dettaglio, prevalentemente in Italia nei 6 negozi di abiti usati e nei tre dedicati al vintage, e in 462 negozi tra Europa ed Usa e all’ingrosso in Europa”. Con i fondi ottenuti si finanziano progetti localmente.