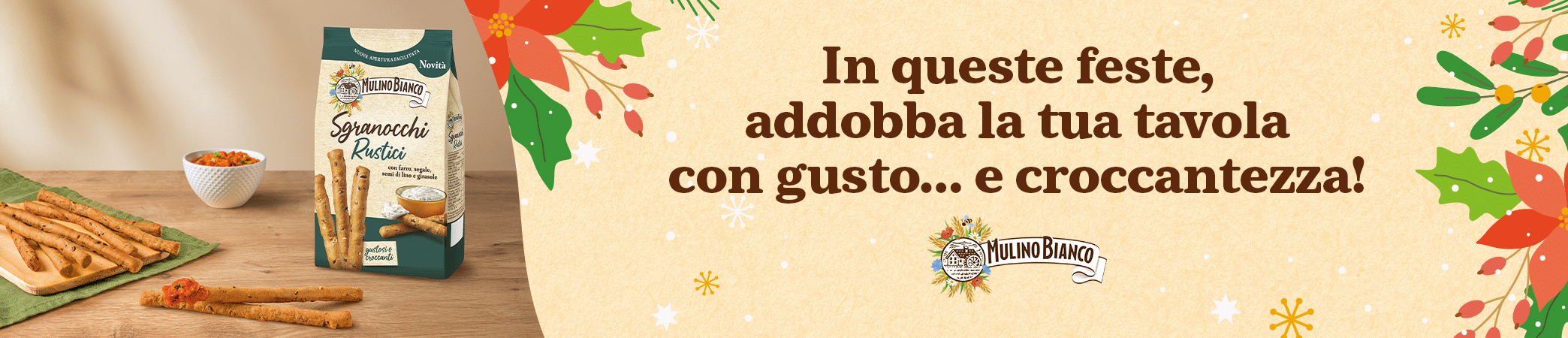Dal metodo di salatura all’affumicatura, dal profilo nutrizionale al benessere animale: il salmone affumicato non è tutto uguale. Dai test del Salvagente cerchiamo di capire come scegliere consapevolmente, evitando rischi per salute e ambiente
Il salmone affumicato è uno dei prodotti ittici più presenti sulle tavole italiane, non solo nelle feste. Ma dietro il colore invitante delle fette rosa si nascondono differenze enormi di qualità nutrizionale, impatto ambientale e benessere animale. Le inchieste e i test di laboratorio del Salvagente mostrano come leggere con attenzione l’etichetta sia un passo – non l’unico, come vedremo, ma il solo che può fare chi non dispone di un laboratorio per trovare anche quello che non si vede in apparenza – per evitare brutte sorprese.
Etichetta sotto la lente: cosa conta davvero
Il primo errore che si può fare è giudicare il salmone dall’aspetto. La qualità si gioca soprattutto nelle diciture, spesso poco evidenti.
La salatura è uno degli indicatori chiave. Meglio scegliere prodotti “salati a secco”: il sale viene applicato manualmente sul filetto, garantendo una carne più compatta e una migliore conservazione. La salatura per iniezione di salamoia, invece, gonfia le carni d’acqua, ne peggiora la consistenza e aumenta artificialmente il peso.
Attenzione poi all’affumicatura. In etichetta dovrebbe comparire la parola “affumicato”, meglio se accompagnata dall’indicazione del legno utilizzato, come il faggio. La dicitura “aroma di affumicatura” segnala invece l’uso di fumo liquido: il pesce non è mai passato in affumicatoio, ma immerso in un preparato chimico.
Conta anche la specie. Il più diffuso è il Salmo salar (salmone atlantico), quasi sempre di allevamento, spesso proveniente da Norvegia o Scozia. Chi cerca un prodotto selvaggio deve orientarsi su altre specie, come il Sockeye del Pacifico, riconoscibile per le carni più rosse, magre e dal sapore deciso.
Dal punto di vista nutrizionale, il parametro più importante è il rapporto tra Omega-3 e Omega-6. Nei salmoni selvaggi e in quelli biologici il contenuto di Omega-3, grassi con effetto antinfiammatorio, è nettamente superiore, come ha dimostrato un test del Salvagente. Negli allevamenti intensivi, l’uso di mangimi a base di mais e soia altera il profilo lipidico, aumentando gli Omega-6, associati a processi pro-infiammatori. In alcuni casi il rapporto può essere fino a dieci volte peggiore rispetto al salmone selvaggio.
Spiegava Debora Rasio, oncologa e nutrizionista, al nostro giornale: “
“Abbiamo dei salmoni che non mantengono più la promessa di essere una fonte di lipidi buoni, capaci cioè di evitare lo stress ossidativo. La causa? L’alimentazione negli allevamenti”
Infine, il peso effettivo. I controlli del Salvagente hanno evidenziato scostamenti anche significativi tra peso dichiarato e peso reale, con differenze arrivate fino al 14% in alcuni lotti.
Benessere animale: una questione ignorata
L’immagine patinata del salmone affumicato nasconde una realtà molto meno appetibile. L’allevamento intensivo solleva seri interrogativi sul benessere dei pesci, ormai riconosciuti come esseri senzienti.
Nelle grandi gabbie marine possono convivere fino a 300 mila esemplari, stipati in spazi ristretti che impediscono comportamenti naturali e aumentano stress e aggressività. Le alte densità favoriscono la diffusione del sea lice, il pidocchio di mare, un parassita che si nutre delle carni dei pesci ancora vivi.
La crescita forzata, resa possibile da mangimi iperproteici, ha conseguenze pesanti: secondo studi scientifici, fino al 95% dei salmoni allevati presenta deformazioni ossee e disturbi sensoriali come la sordità.
Critico anche il momento dell’abbattimento. In molti allevamenti i pesci vengono lasciati morire per asfissia o immersi in miscele di acqua e ghiaccio, con un’agonia che può durare anche 40 minuti. Metodi più rapidi e meno dolorosi, come lo stordimento elettrico, esistono ma sono ancora poco diffusi, nonostante incidano sul costo finale per pochi centesimi al chilo.
L’impatto ambientale degli allevamenti intensivi
L’acquacoltura industriale viene spesso presentata come alternativa sostenibile alla pesca, ma i dati raccontano un’altra storia.
Un singolo impianto di allevamento scarica in mare tonnellate di rifiuti organici, nitrati, fosforo, residui di mangimi e farmaci veterinari, contribuendo all’eutrofizzazione delle acque e alla formazione di vere e proprie “zone morte” sui fondali.
C’è poi il problema della resa alimentare: per produrre un chilo di salmone di allevamento servono in media circa cinque chili di pesce selvatico, trasformato in farina e olio. Una sottrazione di risorse che pesa soprattutto sui paesi più poveri, dove quelle stesse specie potrebbero essere destinate al consumo umano.
Come ha già spiegato Silvio Greco, biologo ed esperto di Slow Food, in più di un’occasione
“per la prima volta nella storia, l’uomo sta allevando animali carnivori, dei predatori. Tutto ciò sta producendo un impatto enorme sul nostro ecosistema: stiamo trasformando proteine a basso costo in proteine ad alto costo. Uno spreco di risorse assurdo”.
Infine, le fughe dagli allevamenti. I salmoni che scappano dalle gabbie possono trasmettere malattie alle popolazioni selvatiche e alterarne il patrimonio genetico, mettendo a rischio la sopravvivenza delle specie autoctone.