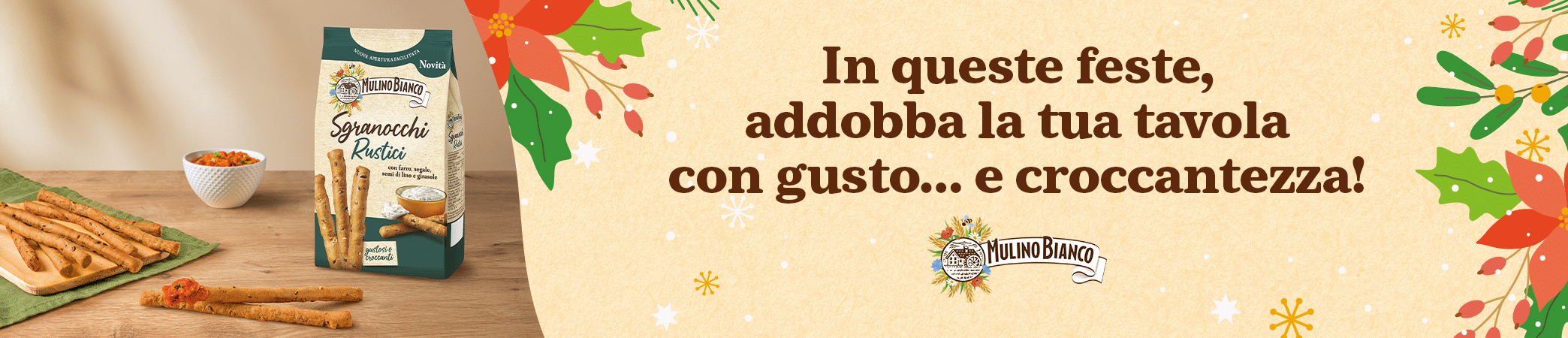L’Italia aderisce ufficialmente all’alleanza Ue sul nucleare, che promuove gli interessi dei Paesi favorevoli all’atomo. Eppure, rimangono molte perplessità sull’efficacia e sull’attuabilità del modello di nucleare che il governo italiano vorrebbe applicare
L’Italia aderisce ufficialmente all’alleanza Ue sul nucleare, dopo avervi preso parte finora in qualità di osservatore. Lo ha annunciato il ministro della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in occasione della nuova riunione dell’alleanza a margine del Consiglio Energia a Lussemburgo. L’iniziativa, guidata dalla Francia, è nata nel 2023 per promuovere gli interessi dei Paesi favorevoli all’atomo. Oltre a Roma e Parigi, vi aderiscono Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Eppure, rimangono molte perplessità sull’efficacia e sull’attuabilità del modello di nucleare che il governo italiano vorrebbe applicare.
Il governo italiano ha rilanciato un progetto di “nucleare sostenibile”. A raccontarlo è Maurizio Bongioanni nel numero di giugno del Salvagente, di cui riportiamo alcuni passaggi.
A marzo 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge delega che introduce l’energia nucleare “di nuova generazione” (e la fusione nucleare) tra le opzioni disponibili per la transizione energetica del paese. La proposta, promossa dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, punta a integrare queste tecnologie nel percorso di decarbonizzazione previsto per il 2050. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri è una legge delega, quindi non è immediatamente operativo. Deve prima passare l’esame di Camera e Senato. Una volta approvato, definirà i princìpi che guideranno il governo nella reintroduzione dell’energia nucleare in Italia.
L’entusiamos di Pichetto Fratin
Detto questo, secondo Pichetto Fratin “il nucleare di nuova generazione, insieme alle rinnovabili, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi climatici garantendo la sicurezza energetica dell’Italia”. Il governo ritiene dunque che questa fonte energetica possa rispondere alla crescente domanda di elettricità, rafforzando l’indipendenza energetica e riducendo le emissioni di CO2. L’obiettivo dichiarato è quello di coprire tra l’11% e il 22% del fabbisogno nazionale con l’energia nucleare entro il 2050, affiancandola appunto alle rinnovabili. Nel 2015, però, le rinnovabili coprivano circa il 33% del fabbisogno elettrico nazionale: nel 2024, questa quota è salita al 41,2%, segnando una crescita sostenuta. Lo stesso non si può dire della produzione nucleare, che invece deve partire da zero dopo oltre trent’anni di inattività.
Cosa prevede il disegno di legge
Il nuovo nucleare dovrebbe distinguersi nettamente dagli impianti del passato, ormai in fase di smantellamento. Il piano del governo apre all’adozione di reattori modulari di piccole dimensioni (Smr), anche di iniziativa privata, e la creazione di un’authority indipendente per la sicurezza nucleare. La legge dovrebbe disciplinare l’intero ciclo di vita degli impianti, dalla progettazione alla dismissione, con un’attenzione particolare alla gestione dei rifiuti radioattivi e allo stoccaggio in sicurezza. Le aziende coinvolte dovranno dimostrare di poter sostenere i costi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti, oltre ai rischi connessi. Sarà necessaria una stretta collaborazione con i gestori delle reti elettriche per valutare l’impatto sul mercato nazionale. Nei prossimi 12 mesi, il governo dovrà emanare i decreti attuativi per avviare sperimentazioni, individuare i siti e costruire i nuovi reattori. Sono previsti incentivi economici per i territori che accetteranno di ospitare le infrastrutture.
Cosa sono gli Smr
Ma cosa sono gli Smr? Per rispondere a questa domanda, è prima necessario capire a che punto è la tecnologia del nucleare. Gli impianti più recenti e in funzione sono conosciuti come Epr, cioè reattori nucleari ad acqua pressurizzata, cosiddetti “di terza generazione”. Secondo la World Nuclear Association, nel mondo vi sono 440 reattori nucleari in funzione per la produzione elettrica a fini civili (ai quali si aggiungono reattori con finalità diverse, tra cui quelli di ricerca scientifica), 66 si trovano in fase di costruzione e 85 in fase di progettazione. A questi ancora si aggiungono più di 300 proposte di realizzazione. I reattori Epr hanno una caratteristica che li contraddistingue: hanno costi e tempi di realizzazione estremamente elevati. Soprattutto in Europa: due esempi emblematici sono il reattore Olkiluoto situato in Finlandia e il Flamanville in Francia. La costruzione del primo è iniziata nel 2005 e avrebbe dovuto concludersi nel 2009. Tuttavia, il progetto ha subito una serie di ritardi e problemi tecnici, portando al completamento solo nel 2023, con un ritardo di 14 anni e con costi che sono schizzati da 3 miliardi a oltre 12 miliardi di euro. I lavori del reattore Flamanville sono invece iniziati nel 2007 con l’obiettivo di completamento entro il 2012, ma anche qui una serie di difficoltà tecniche e gestionali hanno causato ritardi di 12 anni, portando al suo collegamento alla rete elettrica solo nel dicembre 2024. Per questo reattore si sono spesi 19,1 miliardi di euro (contro una previsione di 3,4) e sebbene sia collegato ufficialmente da dicembre 2024 alla rete elettrica nazionale, da febbraio e fino alla data di chiusura di questo giornale (maggio scorso) non ha immesso energia (e ciò fa supporre che nemmeno tra dicembre e febbraio il reattore abbia immesso elettricità prodotta da fissione nucleare).
I ritardi
Va detto che i ritardi sono dovuti, almeno in parte, alla presenza di agenzie per la sicurezza nucleare indipendenti dai governi nei paesi democratici. Per questo, la maggior parte dei nuovi impianti Epr viene realizzata in paesi con regimi autoritari, dove le procedure sono meno soggette a vincoli di trasparenza e controllo. I naturali successori degli Epr sono i reattori di quarta generazione, che hanno l’obiettivo di essere più sicuri, efficienti e sostenibili: alcuni modelli utilizzerebbero combustibile autofertilizzante, riducendo le scorie, o impiegherebbero raffreddamenti a gas, piombo o sali fusi, migliorando la sicurezza delle centrali. Al momento, però, non esistono reattori di quarta generazione operativi su scala commerciale ma solo impianti sperimentali. Per questo, non rappresentano un’opzione praticabile in relazione agli obiettivi energetici e climatici al 2030 e, salvo progressi tecnologici straordinari, difficilmente lo saranno per il 2050.
Il modello tricolore
I reattori di terza e quarta generazione non sono all’ordine del giorno, almeno per il nuovo piano italiano. Il ministro Pichetto Fratin, in un’audizione parlamentare dell’ottobre 2024, ha escluso qualsiasi interesse per i reattori di attuale generazione, poiché questi impianti non sono adatti a integrarsi in sistemi elettrici con un’elevata quota di fonti rinnovabili e poiché la loro rigidità operativa contrasta con la flessibilità richiesta da un mix energetico basato su solare ed eolico. L’intento del disegno di legge italiano è piuttosto quello di favorire i reattori modulari di piccole dimensioni (Small modular reactors, Smr), che vanno a ridurre la scala delle tecnologie nucleari esistenti di terza generazione. Si tratta di reattori con una capacità massima di 300 MW ciascuno e si ispirano ai piccoli reattori di propulsione di navi e sottomarini bellici. Attualmente, ne esistono due (c’è chi dice tre), di cui uno in Cina e uno galleggiante al largo delle coste siberiane, in Russia. Il vantaggio principale degli Smr sarebbe quello di poter essere assemblati direttamente negli stabilimenti dei costruttori, con un elevato grado di standardizzazione che ne ridurrebbe i costi di installazione. Ma nonostante la Nuclear Energy Agency (Nea) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) abbia previsto la realizzazione di 50 reattori Smr nel 2022, a oggi non ve n’è ancora uno in fase di realizzazione, al di fuori degli unici due citati.
Il punto debole secondo l’esperto del Cnr
“Un conto è costruirne uno, un conto è creare una filiera per la produzione di reattori in serie”, spiega al Salvagente Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). “Inoltre, quanto vale il mercato di questi reattori non è dato saperlo, perché non c’è ancora alcun business plan a riguardo. Ma il governo punta sugli investimenti dei privati: in pratica è il de profundis per il piano, mentre giace ancora nella culla. Infatti, rilanciare il nucleare senza ingenti investimenti pubblici, come avviene in tutto il mondo, è impensabile. Nessun investitore privato è disposto a investire miliardi in un progetto che potrebbe dare risultati solo tra 15-20 anni”.
Poche certezze
Inoltre, i progetti di Smr non stanno producendo i risultati sperati. Nel 2024, la società francese Edf, uno dei maggiori produttori di energia elettrica al mondo (con il 74% della produzione nucleare), ha annunciato lo stop di Nuward, la sua filiale dedicata allo sviluppo di Smr, dopo quattro anni di lavori. Edf ha spiegato che sta rivedendo la missione della sua divisione, poiché non ci sono certezze sui tempi di realizzazione e sui costi finali. L’anno precedente, la stessa decisione era stata presa da NuScale, l’azienda americana che per prima aveva ottenuto l’autorizzazione a commercializzare un reattore Smr da 77 Megawatt.