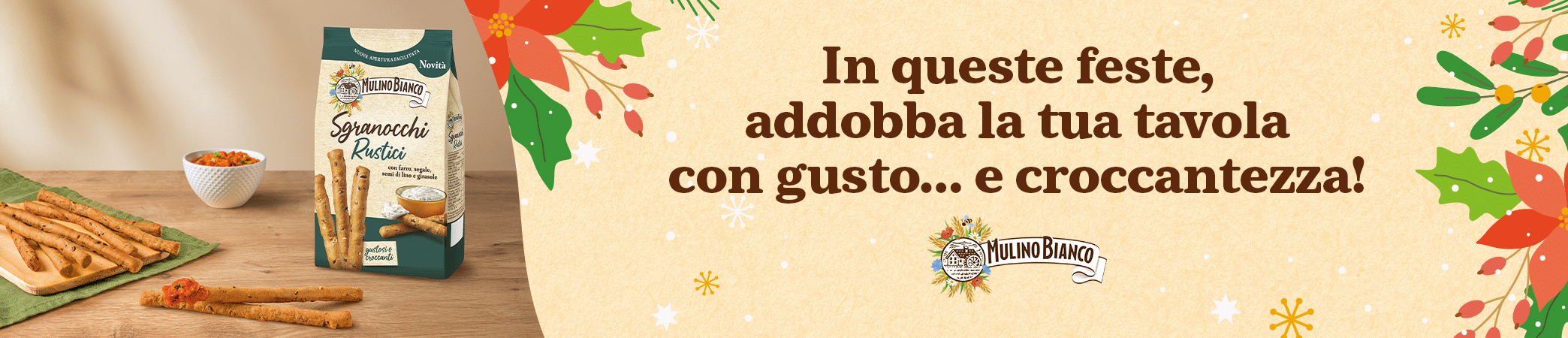Migliaia di prodotti alimentari contengono nanoparticelle senza dichiararle. È il succo di un’inchiesta francese. Gli additivi più sospetti? E170, E551, E341 ed E174
A nostra insaputa, migliaia di prodotti alimentari industriali contengono nanoparticelle, particelle minuscole dal diametro inferiore ai 100 nanometri (nm), ovvero un decimilionesimo di metro. Per di più silenziosamente, ossia senza che i consumatori possano rendersene conto. È il succo di un’inchiesta appena pubblicata dal magazine dei consumatori francesi 60 millions de consommateurs.
Spiega al giornale trasalpino Francelyne Marano, professore emerito di biologia cellulare e tossicologia presso l’Università di Parigi, “la forma nanometrica conferisce a questi additivi proprietà particolari”. Ad esempio, l’ossido di ferro, in forma nano, colora di rosso alcuni dolciumi.
Indicazione obbligatoria (o forse no)
Dal 2014, una normativa europea obbliga i produttori a indicare la presenza di nanoparticelle, inserendo la dicitura “nano” davanti agli ingredienti interessati. Tuttavia, secondo il reportage dei nostri colleghi francesi, questa indicazione è praticamente assente sulle etichette, nonostante l’evidente uso industriale di queste sostanze.
In particolare, ingredienti come il carbonato di calcio (E170) o la silice amorfa (E551), notoriamente usati anche in forma nano, sono largamente presenti in molti alimenti senza alcuna indicazione specifica. Questo accade perché la definizione europea considera “nano” un materiale solo se almeno il 50% delle particelle ha dimensioni comprese tra 1 e 100 nm. Di conseguenza, se un prodotto ne contiene “solo” il 49%, non scatta l’obbligo di dichiararlo in etichetta.
Anna Bencsik, direttrice di ricerca presso l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza alimentare (Anses), è tra i tanti esperti che non ritengono che questa soglia del 50% rispetti il principio di precauzione e si auspica una definizione più restrittiva. Anses aveva già suggerito, nel 2020, di includere nella definizione qualsiasi aggregato di particelle inferiori a 100 nm, indipendentemente dalla percentuale.
Gli additivi nano più diffusi
Tra gli additivi più diffusi vi è proprio il carbonato di calcio (E170), che si trova in prodotti come chewing-gum Hollywood alla clorofilla, barrette ai cereali Kellogg’s, pizze surgelate Picard e bevande vegetali Alpro. Altro esempio preoccupante è l’E551 (silice amorfa), costituito interamente da nanoparticelle tra 10 e 20 nm. Studi recenti condotti da Eric Houdeau dell’INRAE hanno mostrato come l’esposizione cronica all’E551 possa favorire allergie alimentari e infiammazioni intestinali simili alla celiachia nei topi.
Anche fosfati di calcio (E341), molto utilizzati in biscotti come i Pépito al cioccolato al latte Lu e nel formaggio Pik & Croq de La Vache qui rit, hanno dimostrato una presenza certa in forma nano, con possibili rischi per la salute.
L’argento nano (E174), impiegato in confezioni e alimenti per le proprietà antimicrobiche, è un’altra sostanza preoccupante: una volta ingerito, si trasforma in ioni argento tossici, capaci di raggiungere persino il cervello.
Poca trasparenza sulle nanoparticelle
La trasparenza resta però un problema: molti additivi, come la silice amorfa, sono utilizzati come ausili tecnologici e non compaiono obbligatoriamente in etichetta, lasciando il consumatore ignaro dell’effettiva esposizione.
In Francia, dal 2013, esiste il registro R-Nano che traccia la produzione e l’importazione di nanomateriali. Tuttavia, rimane difficile valutare con precisione l’entità del fenomeno nell’alimentazione, considerando che nel solo 2022 sono state prodotte oltre 236.000 tonnellate di nanoparticelle.
Nonostante alcuni passi avanti, come il divieto europeo del biossido di titanio (E171) per la sua tossicità, confermata nel 2020 da studi scientifici, la ricerca sui rischi legati alle nanoparticelle procede lentamente e senza sufficiente finanziamento pubblico o privato.
Resta dunque cruciale chiedere una maggiore trasparenza e rigorosità nelle normative europee, affinché il consumatore possa conoscere realmente cosa finisce nel proprio piatto, concludono i francesi. Come non essere d’accordo?