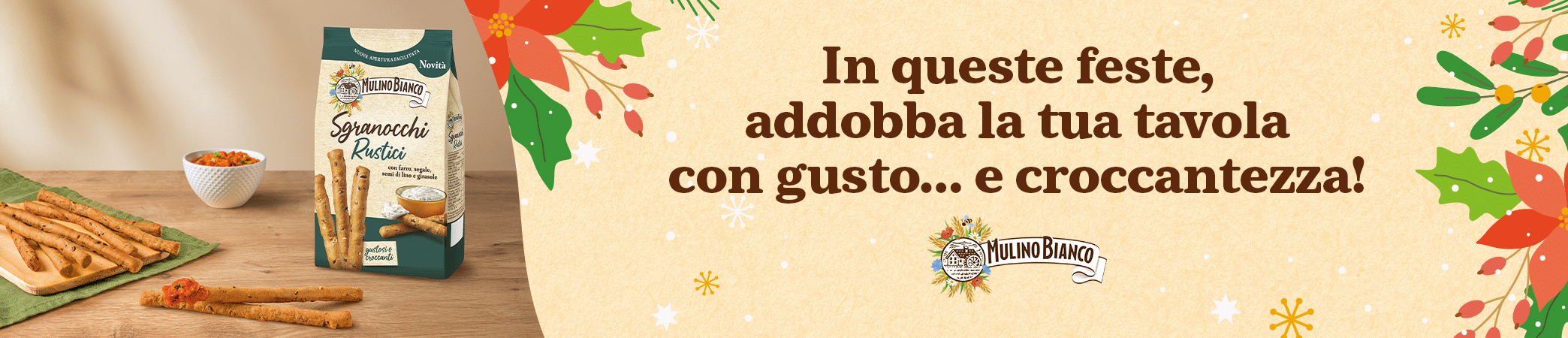Anni di studi e ricerche hanno spinto l’industria degli snack a studiare attentamente il suono che i loro prodotti fanno sotto i nostri denti. Che influenza il giudizio sull’alimento e la quantità che ne mangeremo. Ecco cos’è l’effetto crunch
Abbiamo letto molte volte (l’ultima grazie a un bell’articolo del nostro Dario Vista) quanto potere abbia sul nostro “appetito” il gusto di insaporitori come il glutammato, studiati per catturare i nostri sensi e spingerci a mangiare sacchetti interi di snack, senza fermarci.
Poco, invece, si dice di uno degli aspetti più cari alle industrie alimentari: il suono che hanno i loro prodotti una volta sgranocchiati dal consumatore. Un fattore sul quale esiste più di una ricerca scientifica che gode della massima attenzione da parte degli esperti di marketing. E che potrebbe essere importante conoscere anche per capire i meccanismi che ci legano a determinati cibi.
L’esperimento dei pretzel
Secondo alcuni ricercatori una maggiore attenzione a questo senso del gusto “dimenticato” potrebbe aiutare i consumatori a evitare l’iperalimentazione, un fenomeno noto come “sinestesia uditivo-gustativa”. Gli esperti lo chiamano effetto crunch, un esperimento che avrebbe dimostrato come il gruppo soggetto ai rumori di sottofondo più forti che annullavano i suoni prodotti mentre mangiavano, ha mangiato quattro pretzel (i pani intrecciati croccanti tipici dell’Alsazia) rispetto ai 2,75 pretzel di quelli consumati in un ambiente silenzioso. Lo studio del 2016 pubblicato su Food Quality and Preference è stato sintetizzato dal coautore Ryan Elder, allora assistente professore di marketing presso la Marriot School of Management della BYU così: “Il suono è tipicamente etichettato come il senso del cibo dimenticato, ma se le persone si concentrano di più sul suono che il cibo produce, potrebbe ridurre il consumo”.
L’effetto crunch
Gli alimenti croccanti (lattuga, patatine) producono tipicamente suoni ad alta frequenza (sopra i 5 kHz) quando vengono mangiati, mentre gli alimenti che scricchiolano (arachidi) producono suoni a una gamma molto più bassa (1-2 kHz). Gli alimenti crepitanti (biscotti secchi) generano invece suoni a bassa tonalità con un alto livello di conduzione ossea, spiegano le ricerche. Il professor William E. Lee già ricercatore sensoriale presso Procter & Gamble prima di unirsi all’Università della Florida del Sud come professore associato di ingegneria chimica e biomedica, ha dichiarato a Food Navigator che i cibi silenziosi non forniscono abbastanza stimolazione e l’esperienza alimentare potrebbe “diventare noiosa più rapidamente”. Dunque, almeno secondo E. Lee, le conseguenze di un “crunch” studiato ad arte stancherebbero meno il consumatore e di conseguenza lo farebbero mangiare di più
Proprio le sue analisi del 1990 hanno rilevato che un prodotto croccante crea suoni ad alta frequenza. Utilizzando un analizzatore di segnali, Lee ha misurato il suono generato da una serie di 10 masticazioni consecutive su patatine e tortillas e ha scoperto che i campioni freschi erano più rumorosi e emettevano suoni a frequenze più alte rispetto ai loro omologhi stantii. Ha anche scoperto che i mangiatori rumorosi godevano di più dell’esperienza, mentre i partecipanti che indossavano cuffie per cancellare il rumore mangiavano meno patatine.
Se il marketing inventa i suoni
Non a caso, fa notare Food Navigator, le campagne di marketing digitale spesso enfatizzano “il crunch” per sottolineare l’attrattiva, coinvolgere gli spettatori e stimolare l’appetito.
L’ultimo decennio, in particolare, ha visto un’esplosione nell’uso di rumori di sottofondo, musica e paesaggi sonori appositamente progettati per migliorare l’esperienza di degustazione. Uno studio del 2016 pubblicato in Multisensory Flavor Perception ha rilevato che il rumore influenza le nostre scelte e il comportamento di consumo, migliorando la nostra sensibilità a cose come la croccantezza e l’umami, ma sopprimendo anche la nostra capacità di assaporare cose come la dolcezza, spiega nel suo approfondimento Gill Hyslop
Quando il suono imita la freschezza
Non basta che i consumatori siano attratti dal suono di un prodotto che stanno sgranocchiando. Si può anche condizionarli a ritenerlo più fresco in base al rumore che fa sotto i denti: un forte crunch è infatti spesso associato alla freschezza e alla qualità, mentre un suono debole può essere percepito come stantio o inferiore.
Uno studio del 2003 pubblicato nel Journal of Sensory Studies ha chiesto ai partecipanti di mordere patatine con i denti anteriori e valutare la loro croccantezza o freschezza. I risultati hanno mostrato che le patatine erano percepite come più croccanti e fresche – che lo fossero o meno – quando il livello sonoro complessivo era aumentato o quando i suoni ad alta frequenza (2 kHz-20 kHz) erano amplificati selettivamente. Un risultato che oramai tutte le aziende di chips conoscono bene e utilizzano.
Più tempo tra i denti, meno sulla lingua
“Più a lungo usi i denti, più croccante è considerato un prodotto,” ha detto il Prof. Lee a Food Navigator. E ha spiegato: “La croccantezza viene percepita in due posti. Uno è nella bocca, dai terminali nervosi inclusi quelli dei denti, che creano una rottura netta, improvvisa e completa, come la frantumazione del vetro. L’altro posto è l’orecchio. Le informazioni uditive sono importanti nella valutazione di un cibo e solo ascoltando, puoi dire se una patatina è fresca o stantia”.
Le conclusioni del professore sono evidenti: “Se il cibo arriva nel mezzo della bocca e la persona usa la lingua per comprimerlo, significa che il prodotto è pastoso. Con uno snack salato, vogliamo massimizzare il tempo dei denti e minimizzare il tempo della lingua”.