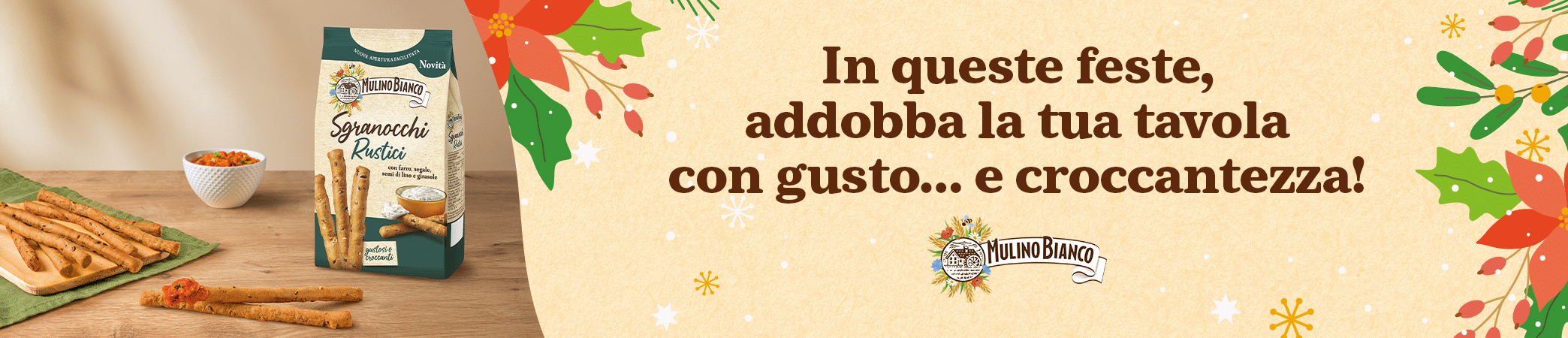Diagnosi poco precise, che generano confusione e cure sbagliate. E terapie intervengono quando il cervello è ormai irrimediabilmente danneggiato dall’Alzheimer. Ma le ultime novità su anticorpi e diagnosi precoce stanno portando a una maggiore conoscenza di una malattia che, solo in Italia, costa 11 miliardi e spaventa anche i più giovani.
Quasi 1 milione e mezzo di italiani soffre di demenza, 600mila di questi sono colpiti da Alzheimer. Sono per lo più stime, perché fino a ieri avventurarsi in questo lato oscuro della mente era come fare un salto nel vuoto.
La prevalenza di questa patologia aumenta con l’età e risulta maggiore nelle donne, che presentano valori che vanno dallo 0,7% per la classe d’età 65-69 anni, al 23,6% per le ultranovantenni, rispetto agli uomini i cui valori variano rispettivamente dallo 0,6% al 17,6%.
Corsa alla diagnosi precoce
Si stima che nel 2040 i malati di Alzheimer in Italia raggiungeranno una quota superiore ai 2,5 milioni con costi sociali e sanitari pesantissimi. Solo in Italia i costi diretti per l’assistenza superano gli 11 miliardi di euro all’anno, il 73% dei quali è a carico delle famiglie. Una speranza è che nel prossimo futuro la malattia sia più facilmente e precocemente individuabile, con conseguenze positive sui trattamenti e sulle terapie.
Il problema dell’Alzheimer, infatti, è la diagnosi non ancora precisa. Spesso la malattia si scoprre quando è ormai troppo tardi per intervenire sul cervello irrimediabilmente danneggiato. Per invertire questa tendenza, la ricerca si sta attivando sulla diagnosi precoce.
In un articolo pubblicato recentemente sul magazine Fondazione Umberto Veronesi sono contenute le ultime novità che riguardano l’utilizzo di biomarker. La strategia del futuro consentirà di individuare questa patologia sempre più precocemente consentendo così di rallentare la malattia con gli anticorpi contro la beta-amilioide che distrugge il cervello.
Ridurre la progressione dell’Alzheimer
Daniele Banfi, biologo specializzato in genetica, e giornalista, nei dettagli dell’articolo su Fondazione Umberto Veronesi spiega come si evolverà il campo della diagnostica di questa atroce malattia neurodegenerativa che, nell’immaginario comune – osserva Banfi – “rappresenta una condanna. Esattamente com’era una diagnosi di tumore prima degli anni ’60”.
Grazie al lavoro dei ricercatori, qualcosa sta cambiando. “Diagnosi precoce, interventi mirati per il decadimento cognitivo e sviluppo di terapie con anticorpi capaci di ridurre la progressione della malattia non sono più un miraggio” – fa notare la dottoressa Maria Teresa Ferretti, neuroimmunologa e responsabile scientifico di Women’s Brain Project (WBP).
Daniele Banfi ricorda che solo poco tempo fa i rischi di stoppare definitivamente la ricerca sull’utilizzo degli anticorpi nell’Alzheimer erano elevatissimi. La tenacia di alcuni studiosi ha fatto sì che questo non accadesse.
La ricercatrice Ferretti fa il punto su come si è arrivati a questa svolta:
“Molti studiosi coinvolti negli esperimenti originali erano ancora convinti che l’idea di sfruttare il sistema immunitario fosse valida e che bisognasse solo trovare il meccanismo giusto. Fra le persone che avevano ricevuto il farmaco e poi decedute – che avevano donato il loro cervello alla scienza – si vide che vaste aree cerebrali erano ripulite dall’amiloide. Nei pazienti che avevano sviluppato anticorpi contro l’amiloide, secondo uno studio, c’era stato persino un misurabile miglioramento cognitivo”.
Per questo, la comunità scientifica sta lavorando per realizzare anticorpi di nuova generazione oggi in fase di sperimentazione.
I nuovi anticorpi
La Fondazione Veronesi riporta i risultati positivi recentemente annunciati dalle case farmaceutiche Biogen e Aisai. Per esempio, Clarityun è un trattamento clinico di fase III con l’anticorpo lecanemab che sta reagendo bene. Dalle analisi è emerso che nei pazienti con lieve declino cognitivo e con presenza di placche beta-amiloidi confermata, il trattamento con questo anticorpo ha portato ad una riduzione della progressione della malattia.
Banfi giustamente sottolinea che questo risultato importante è stato annunciato da un comunicato dell’azienda farmaceutica, dunque bisognerà attendere la presentazione ufficiale dei dati durante il prossimo Clinical Trials on Alzheimer’s Congress. Ma nel complesso è un risultato indicativo, che traccia un solco per il futuro della diagnostica precoce. Gli anticorpi fanno ben sperare circa la possibilità di rallentare l’Alzheimer e l’importanza dell’agire precocemente sulle placche beta-amiloidi. La speranza è che anche gli altri anticorpi in fase di test, avendo sempre come target le placche, possano dare risultati simili.
Perché è difficile la diagnosi
La malattia di Alzheimer finora ha avuto una diagnosi molto tardiva, con conseguente scarsa efficacia della terapia. Colpisce la fascia anziana della popolazione con pesanti ricadute sui costi sanitari e sulla presa in carico sul territorio, con forti disagi per le famiglie. Per i neurologi è molto importante diagnosticare correttamente e prendere in carico anche i pazienti che hanno altre forme di demenza. Come per esempio, la demenza vascolare, la demenza corpi di Lewy, la demenza frontotemporale… O, ancora più frequentemente, la demenza cosiddetta mista.
La sfida dei ricercatori è quella di diagnosticare l’Alzheimer precocemente, rallentando il progresso della malattia. Ma perché la diagnosi è così difficile?
Prima di rispondere alla domanda dobbiamo capire cos’è l’Alzheimer. La malattia di Alzheimer (Alzheimer’s Disease) è una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo. È la causa più comune di demenza nella popolazione anziana dei Paesi sviluppati.
Questa patologia prende il nome dal neurologo tedesco Alois Alzheimer che all’inizio del 1900 ne descrisse per primo le caratteristiche: un processo degenerativo progressivo che distrugge le cellule del cervello, causando un deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive (memoria, ragionamento e linguaggio), fino a compromettere l’autonomia e la capacità di compiere le normali attività giornaliere.
La causa all’origine dell’Alzheimer sembrerebbe essere legata all’alterazione del metabolismo di una proteina, la proteina precursore della beta amiloide (detta APP) che, per ragioni ancora non conosciute, a un certo punto nella vita di alcune persone inizia a venire metabolizzata in modo alterato portando alla formazione di una sostanza neurotossica – la beta amiloide – che si accumula lentamente nel cervello portando a morte neuronale progressiva.
Quali sono le cause dell’Alzheimer
Dai dati disponibili e aggiornati risulta che meno del 5% dei casi di Alzheimer è provocato dalla presenza di un gene alterato che ne determina la trasmissione da una generazione all’altra di una stessa famiglia. I medici dell’IRCCS Humanitas osservano che le forme familiari di Alzheimer hanno insorgenza più precoce, anche prima dei 40 anni, e sono legate alla presenza di varianti nei geni della presenilina 1 (PS1) sul cromosoma 14, della presenilina 2 (PS2) sul cromosoma 1 o della proteina precursore della beta amiloide (APP) sul cromosoma 21. In tutti questi casi la trasmissione ha carattere autosomico dominante.
Il restante 95% dei casi si manifesta in modo “sporadico”, ovvero in persone che non hanno una chiara familiarità con la patologia.
Dunque, perché è così complicato intervenire su questa patologia?
Purtroppo l’Alzheimer è accompagnato da altri danni che colpiscono il cervello. Infatti, più l’età aumenta e più il cervello si danneggia e degenera. Inoltre si registrano spesso degenerazioni che colpiscono aree del cervello che non sono tipiche dell’Alzheimer.
Studi recenti stanno dimostrando che la maggior parte di pazienti con diagnosi di Alzheimer soffrivano di un’altra patologia più complessa. Un filone di ricerca recente ha scopeto che varie malattie neurodegenerative, quali ad esempio il Parkinson e la Sla, sembrano avere una forma di collegamento con l’Alzheimer e altre malattie degenerative.
A oggi solo il 50% delle persone colpite da demenza riesce ad ottenere una diagnosi corretta. L’obiettivo di clinici e ricercatori è quello di raggiungere una diagnosi in vita più precisa e diagnosticare precocemente la malattia. La diagnosi corretta è fondamentale per l’individuazione di una terapia precoce e il conseguente rallentamento della malattia. IKl dubbio, infatti, è che le terapie falliscano forse perché intervengono quando la maggior parte delle funzioni cerebrali sono deteriorate, quindi i farmaci intervengono quando è ormai troppo tardi.
La diagnosi oggi è un percorso lungo e complesso, che richiede visite di valutazione, numerosi esami clinici e strumentali. In questa fase, che per molti pazienti è un vero calvario, si procede per esclusione di tante altre possibili cause di demenza secondarie da patologie trattabili, come la depressione, l’ipotiroidismo, una intossicazione da farmaci, un tumore, l’idrocefalo, l’ematoma subdurale ed alcune deficienze vitaminiche. Muoversi in questa selva oscura diventa davvero complicato.
L’importanza dei biomarcatori
Fondazione Veronesi ricorda che oggi lo scenario è cambiato radicalmente perché finalmente abbiamo a disposizione dei biomarcatori la cui presenza è associata alla malattia. Quindi ci stiamo avvicinando a una diagnosi precisa. Si tratta di biomarcatori per immagini, in cui le lesioni tipiche della malattia possono essere visualizzate con una TAC, e di biomarcatori liquidi, la cui presenza è rilevata nel sangue o nel liquido cefalorachidiano.
La dottoressa Maria Teresa Ferretti spiega perché diventa più semplice individuare la malattia. “Avere a disposizione questi strumenti è di fondamentale importanza. Si stima che al momento il 75% dei casi di demenza al mondo non sia diagnosticato. Poter avere una diagnosi certa è il primo passo verso un approccio personalizzato alla malattia. Non solo, conoscere con anticipo la presenza dei primi segni della malattia è cruciale per monitorare l’evoluzione e intraprendere eventuali correttivi”.
Come riconoscere i possibili segnali
Un passo, seppur minimo, ma importante, possono farlo i pazienti cogliendo i segnali di allerta. I sintomi della malattia di Alzheimer possono variare molto da soggetto a soggetto. In ordine progressivo di tempo, possono presentarsi i seguenti segnali:
- Perdita di memoria (dapprima in forma leggera e poco rilevabile, poi via via più marcata e grave);
- Con il passare del tempo si può andare incontro a difficoltà nell’esecuzione delle normali attività quotidiane con conseguente perdita dell’autonomia;
- disturbi del linguaggio e impoverimento del linguaggio;
- disorientamento spaziale;
- disorientamento temporale;
- depressione;
- disturbi del sonno;
- disturbi comportamentali in stato più avanzato (agitazione, deliri e allucinazioni);
- possibili alterazioni della personalità, risultando meno interessati ai propri hobby o al proprio lavoro.
Test per l’Alzheimer giovanile
La comunità scientifica non ha la certezza che i casi di Alzheimer siano effettivamente in aumento. I numeri in crescita infatti potrebbero essere dovuti al progressivo miglioramento della diagnosi rispetto al passato.
Anche tra i più giovani l’Alzheimer comincia a diventare maggiormente identificabile. I test per diagnosticare una possibile presenza dell’Alzheimer giovanile sono simili a quelli impiegati negli anziani. Si procede con la risonanza magnetica cerebrale per individuare la presenza di raggruppamenti di beta amiloide nel tessuto cerebrale. La presenza di beta amiloide è indicativa, tanto è vero che si accumula maggiormente nella zona del cervello legata alla memoria e alle capacità cognitiva.
La risonanza magnetica e la TAC sono importanti perché permettono di escludere altre patologie con sintomi simili all’Alzheimer.
I fallimenti del passato
Le novità della ricerca sulla diagnosi precoce dell’Alzheimer grazie all’individuazione dei marcatori specifici aprirà la strada – giurano in molti – alla sperimentazione di nuove cure, più efficaci.
La malattia di Alzheimer, essenzialmente, è causata dalla presenza di ammassi di proteina beta-amiloide che danneggia i neuroni. “Ecco perché negli anni – ricorda Banfi – l’obiettivo principale della ricerca è stato quello di creare farmaci in formulazione di anticorpo capaci di intercettare e neutralizzare la proteina anomala che si accumula. Una ricerca che ha portato alla realizzazione dei primi trial clinici che però non hanno fornito inizialmente i risultati sperati. Un “fallimento” che però non ha rappresentato affatto la pietra tombale della ricerca sul ruolo degli anticorpi nell’Alzheimer”.
“Questi studi – ricorda la ricercatrice Ferretti – sono nati male in partenza. In assenza di biomarcatori moltissime persone coinvolte in quei vecchi studi clinici avevano ricevuto un farmaco contro una patologia che non avevano. Non c’era da stupirsi, dunque, dei risultati negativi. La questione dell’assenza dei biomarcatori però non fu la sola: gli anticorpi di prima generazione portarono anche ad effetti collaterali molto importanti e per questa ragione la ricerca ha subito un forte rallentamento”.
Il cocktail personalizzato
Fondazione Veronesi mette in guardia da possibili e facili entusiasmi. Questi nuovi anticorpi non sono la cura definitiva per l’Alzheimer. Piuttosto si sta andando incontro a trattamenti integrati e personalizzati, adeguati al singolo paziente.
L’esperta Ferretti confida: “Credo che l’approccio alla patologia non sarà solo nella capacità di un farmaco ma la cura non sarà altro che l’utilizzo di diverse terapie che andranno a risolvere specifici aspetti dell’Alzheimer. In futuro i pazienti riceveranno una combinazione di farmaci e di trattamenti, un cocktail personalizzato, per gestire la malattia di ciascun individuo. Di fondamentale importanza, proprio come per i tumori, sarà la diagnosi precoce. Solo intervenendo precocemente potremo rallentare la progressione e gestire l’Alzheimer il più a lungo possibile”.