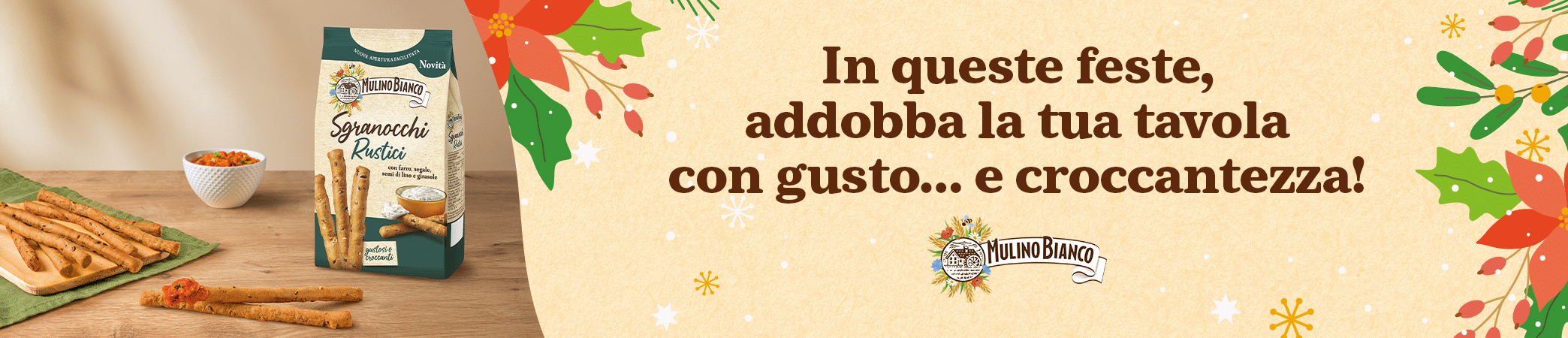Cibo e mente. Cibo industriale e cambiamenti del corpo e della mente. Sono questi i temi che abbiamo affrontato e messo sotto la lente di ingrandimento nell’inchiesta in edicola sull’ultimo numero del Salvagente. Per renderci conto che quando parliamo di cibo, al solito, contano la consapevolezza e la capacità di essere informati. Anche perché, come ci ha spiegato lo psichiatra Paolo Crepet “Il cibo è cultura”. E allora è vero che negli ultimi settant’anni il nostro rapporto col cibo è cambiato, d’altra parte in settant’anni sono cambiate moltissime cose, perché stiamo parlando di un sacco di anni e soprattutto di anni densi di eventi e di innovazioni tecnologiche, che hanno modificato il nostro rapporto con gli altri, con noi stessi e perfino col cibo. Cambiamento però non significa necessariamente peggioramento. Anzi.
Professor Crepet, secondo lei l’industria alimentare ha cambiato la nostra mente?
Mi pare una tesi poco sostenibile e anche molto americana. D’altra parte, possiamo dirlo, gli americani non hanno cultura.
Guardi che lo scrivo…
Va scritto. Tranne qualche eccezione, con radici italiane o europee, gli americani non hanno una cultura alimentare. E invece l’alimentazione dipende dalla cultura, ma non tutti abbiamo la stessa. E c’è chi, come loro, non ne ha molta. Anzi, non ne ha. Poi va considerato che a cambiare è il rapporto fra il cibo e i tempi della vita. Faccio un esempio, mio padre tornava tutti i giorni a casa a pranzo, oggi è impensabile riuscirci. Mia madre cucinava, oggi lo si fa in occasioni particolari, con tempi diversi da quelli del passato. D’altronde se si parla di cibo occorre anche pensare che non solo fa bene di per sé, ma per l’aspetto culturale e sociale. Il cibo fa bene a chi lo cucina, ma anche chi viene accolto. Insomma il cibo fa bene per tutti i dintorni del cibo. Pensiamo a una famiglia che cena assieme, a due amiche che si incontrano per pranzo e per chiacchierare. Il cibo è anche socialità. Lo so bene. Mia moglie ha un piccolo hotel, si chiama “Corte della Maestà”, a Civita di Bagnoregio ed è un bellissimo osservatorio per me.
Che cosa ha osservato, cosa succede quando arrivano gli americani?
Sono dei bambinoni, impazziscono per il cibo. Le cooking class sono state inventate per loro. D’altra parte non hanno negli Usa la varietà di cibo che abbiamo noi, né la nostra cultura.
Ci sono però altri elementi da considerare, per esempio i cambiamenti sociali.
Certo, pensiamo ai single. Oggi è normale per una persona decidere di non mettere su famiglia, un tempo era quasi impensabile. E c’è tutto un fenomeno di porzioni di cibo per i single. Vorrei però citare altri due fenomeni”.
Mi dica…
Ha notato che nel nostro Paese il successo dei vari programmi televisivi dedicati alla cucina ha preso piede subito dopo la crisi del 2008? Beh, è sintomatico. Perché ci si è resi conto che non si poteva più andare a cena fuori tutte le sere, si è tornati in casa, magari con gli amici e si è iniziato a guardare il cibo seduti sul divano o a tavola con gli amici in tv. Analogamente si è sviluppata la musica da casa e i giochi di società. Insomma si è in parte tornati a cucinare per sé e per gli amici, a casa. Anche questo è un fenomeno sociale di gande cambiamento. È una nuova socialità ed è interessante.
Negli stessi anni il cibo è diventato popolare in Italia, tanto che si sono moltiplicati i corsi di cucina e anche quelli di cultura del vino.
E’ vero. E anche questo è sintomo di una nuova socialità, perché così quando si va in enoteca si fa bella figura, ma anche quando vengono gli amici a casa, si sceglie la bottiglia giusta. Tutto questo è cultura. Davvero, in America non c’è niente di simile.
Gran parte dell’inchiesta che abbiamo pubblicato sul Salvagente indaga quanto è cambiato il nostro modo di cibarci. In breve oggi facciamo colazione in maniera diversa da come la faceva mia nonna.
Certo, ma non facciamo l’elegia della nonna, per favore! Perché se sua nonna avesse avuto quello che ha lei oggi lo avrebbe mangiato. In realtà nel dopoguerra c’era tanta povertà, tanta scarsità, con esiti drammatici. I manicomi erano pieni di persone affette da scorbuto e pellagra. Erano le malattie della povertà. Si stava forse meglio? Non direi proprio. Quindi bisogna capire cosa significa industrializzazione, senza demonizzarla e senza a tutti i costi osannare il tempo che fu, perché la fame non era certo una gran roba.
Veniamo all’industria alimentare: tutto da buttare?
Al contrario. Se riesco a migliorare geneticamente una pianta, un animale e se questo aiuta a sconfiggere la povertà, ben venga. Io non sono contrario all’industrializzazione se migliora il nostro modo di vivere. Temo molto di più la cultura del senza.
È ciò che lei denuncia anche nel suo ultimo libro “Passione” (Mondadori). A proposito della paura lei stigmatizza proprio le ossessioni alimentari. Come mai?
Il cibo non può essere paura. La cultura del senza, senza lattosio, senza glutine, senza zucchero, senza burro è un’attenzione talvolta maniacale che porta a delle ossessioni. E inoltre mangiare cose senza, cioè in ultima analisi senza sapori porta ad una certa malinconia. Invece in materia di cibo, socialità, tanto più se parliamo del rapporto fra cibo e mente dobbiamo avere l’intelligenza di conoscere, di mediare, di decidere.
In breve di essere consapevoli e informati?
“Direi proprio di sì. E poi, pensiamo che il cibo fa bene per ciò che ha attorno, per chi si è preso cura di noi, cucinando una cosa che ci piace, per la socialità, per le risate fra amici. Pensiamo meno alle calorie e più alla socialità, questo di certo ci fa bene.