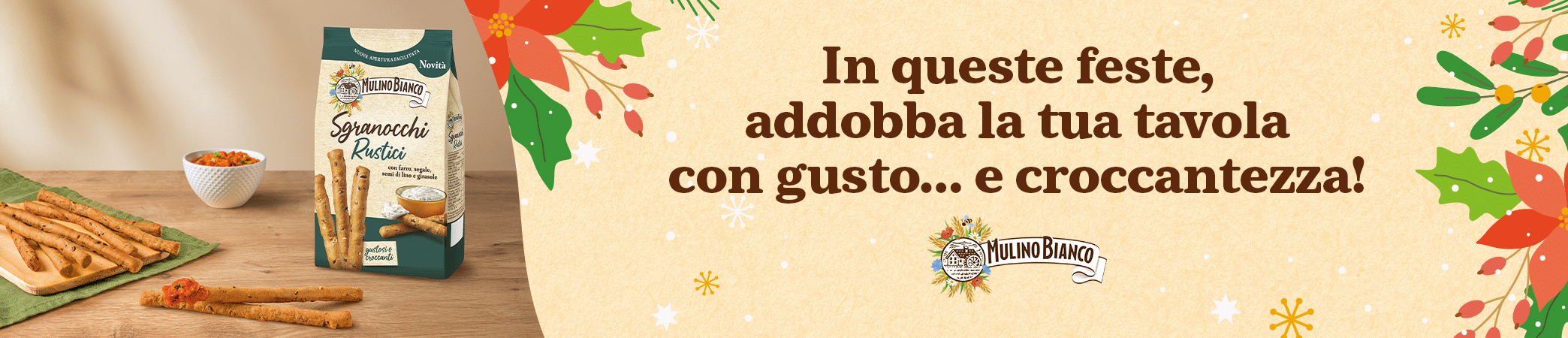L’insetticida Acetamiprid, molto comune anche nel miele italiano, oltre a essere un killer per le api è più pericoloso di quanto si pensasse per gli insetti utili. La nuova ricerca
L’insetticida Acetamiprid, appartenente alla famiglia dei neonicotinoidi e frequentemente rilevato nelle recenti analisi condotte dal Salvagente sul miele italiano, è risultato essere oltre 11.000 volte più tossico per alcuni insetti benefici rispetto a quanto metta a rischio le api mellifere, gli insetti comunemente utilizzati nei test ufficiali di valutazione del rischio dei pesticidi.
Uno studio dettagliato realizzato dall’Università di Hohenheim, in Germania, evidenzia chiaramente l’urgenza di una profonda revisione del sistema europeo di valutazione del rischio per i pesticidi. L’Acetamiprid, che è l’unico neonicotinoide ancora autorizzato nell’Unione Europea per l’uso in campo aperto, mostra effetti particolarmente devastanti su numerosi insetti “non bersaglio”, in particolare sulle cimici delle piante appartenenti alla famiglia Miridae. Questi insetti svolgono un ruolo chiave per il corretto equilibrio degli ecosistemi agricoli, essendo una fonte fondamentale di nutrimento per molte specie di uccelli e predatori naturali.
Le nostre analisi: presente in 9 mieli su 14
Le analisi prtesentate dal numero di marzo del Salvagente confermano la presenza diffusa
di Acetamiprid in campioni di miele italiano, ponendo preoccupazioni sia per la tutela della biodiversità sia per la sicurezza alimentare. La presenza ricorrente di questo pesticida nel miele testimonia l’ampio uso agricolo dell’Acetamiprid nel nostro paese e il conseguente rischio di esposizione cronica per consumatori e ambiente.
Secondo i ricercatori tedeschi, anche concentrazioni di Acetamiprid significativamente inferiori a quelle normalmente applicate in agricoltura hanno provocato effetti catastrofici sugli insetti utili. Gli esperimenti condotti sul campo hanno dimostrato una riduzione fino al 92% delle popolazioni di cimici entro pochi giorni dal trattamento, persino nelle aree marginali che ricevono quantità ridotte del pesticida. Inoltre, gli effetti negativi non si limitano alla fase immediatamente successiva al trattamento: tracce del pesticida sono state rilevate nei tessuti vegetali fino a 30 giorni dopo l’applicazione, prolungando così l’esposizione e il rischio per la fauna selvatica.
Protocolli europei da ripensare
Gli autori della ricerca sottolineano che gli insetti fitofagi, nonostante rappresentino circa la metà di tutte le specie di insetti al mondo, non sono attualmente inclusi nei protocolli ufficiali europei di valutazione della tossicità dei pesticidi. Questa lacuna normativa rende difficile prevedere con accuratezza l’impatto reale degli insetticidi sulla biodiversità. Pertanto, gli studiosi raccomandano vivamente di ampliare significativamente i test di sicurezza, includendo una gamma molto più vasta di insetti, e di aumentare il fattore di sicurezza attualmente utilizzato nelle valutazioni da 10 ad almeno 1.000, al fine di considerare adeguatamente le differenze di sensibilità tra le varie specie e tra i sessi degli insetti.
Infine, il gruppo di ricerca pone un’attenzione particolare sulla necessità di tutelare maggiormente le fasce marginali dei campi agricoli, oggi spesso trascurate dalle normative ambientali. Queste aree svolgono infatti una funzione fondamentale come rifugio per numerosi insetti e animali selvatici, contribuendo in maniera significativa alla biodiversità e al mantenimento dell’equilibrio ecologico. In Italia, dove il Salvagente ha evidenziato la diffusione dell’Acetamiprid nel miele, emerge chiaramente l’urgenza di interventi normativi più stringenti per ridurre drasticamente la contaminazione ambientale e garantire la tutela degli ecosistemi, della biodiversità e della salute dei consumatori.