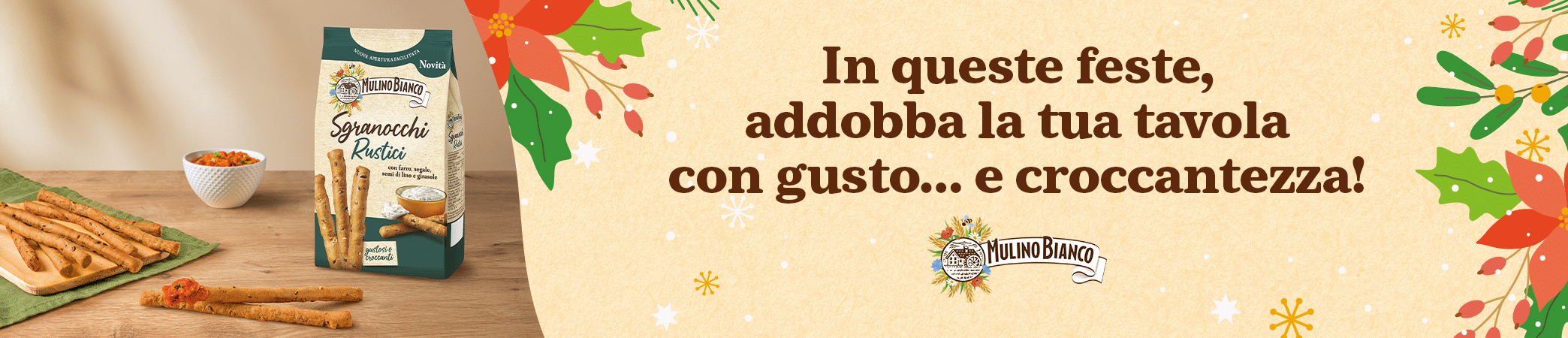Pubbliredazionale a cura di Unioncamere
Secondo i dati della FAO raccolti nel 2017 nel mondo vengono consumati annualmente circa 153 milioni di tonnellate di pesce, per una quota pro capite di 20 kg/anno. A fare da traino è l’Unione Europea, leader in termini di consumi di prodotti ittici, con una media di 25 kg.
L’Europa, insomma, è la regione del mondo in cui si consuma più pesce e l’Italia è ai vertici di questa classifica con una media, sempre in base ai dati FAO, di 28 kg pro capite. Un fabbisogno solo parzialmente soddisfatto dalla produzione interna. Si stima infatti che l’UE attualmente sia in grado di fronteggiare il 44% della domanda (fonte UMOFA sulla base dell’elaborazione di dati EUROSTAT) grazie alle risorse prodotte (tra pescato e acquacoltura), mentre il restante 56% è frutto di importazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Solo l’Italia importa mediamente 440mila tonnellate di pesce all’anno, per un valore di circa 1,8 miliardi di euro, ovviamente con livelli diversi a seconda della specie (i crostacei e i pesci d’acqua dolce godono di un’importazione più elevata poiché meno prodotti internamente).
Filiere lunghe e a tratti lunghissime
Un flusso così importante di prodotti in ingresso getta inevitabilmente dei dubbi sul problema della sostenibilità ambientale e della qualità del prodotto finale. Un fabbisogno alimentare di tali proporzioni rischia di nascondere prodotti meno controllati e frutto di allevamenti dotati di standard meno rigorosi rispetto a quanto previsto dalle norme italiane, soprattutto quando la filiera di provenienza non è sufficientemente trasparente da garantire sicurezze per il consumatore finale. Non sono poche le realtà commerciali che si affidano a fornitori opachi garantendo copiosi approvvigionamenti provenienti da allevamenti intensivi, magari da paesi dove le norme igienico-sanitarie sono meno stringenti rispetto all’Europa oppure ad essere più blandi sono i controlli nei vari step di produzione.
Questo rappresenta un campanello d’allarme importante su cui il Parlamento Europeo dibatte sin dall’inizio degli anni 2000, quando diverse risoluzioni gettarono le basi per la costituzione e il mantenimento, in termini di sovvenzioni, di realtà di acquacoltura che rispettassero tutti gli standard di qualità, le norme a difesa del territorio nonché la domanda commerciale del momento. I numerosi cambi di rotta e l’assenza di una regolamentazione chiara e ufficiale in tal senso hanno tuttavia generato nel tempo una confusione sempre maggiore sul prodotto ittico importato, con risultati preoccupanti in merito a metodologie di allevamento e soprattutto di importazione di pesce dall’Europa o dai paesi extra-UE.
L’esempio greco
Un contesto che non può non richiamare l’attenzione sull’esempio greco, dove negli ultimi anni sono emerse numerose criticità in ambito di produzione ittica sul versante costiero occidentale di Etolia-Acarnania e delle isole Kalamos e Kastos, vere e proprie zone franche per allevamenti intensivi sull’onda di normative accomodanti e un conseguente utilizzo smodato di antibiotici (ad uso preventivo) e formaldeide nelle acque interessate.
Tutto questo, unito ad esempi similari in diverse zone costiere europee ed extra-europee, non fa che alimentare un giustificato timore sul consumo di pesce d’allevamento da parte dei cittadini, condizionati da uno storico tutt’altro che incoraggiante, almeno per quanto riguarda specifiche realtà commerciali.
Non stupisce dunque che il pesce da cattura sia universalmente accettato mentre quello da acquacoltura venga ricollegato a una qualità inferiore.
C’è acquacoltura e acquacoltura
Vero è che come per ogni scenario del mondo alimentare è importante fare dei distinguo che consentano di valutare prodotti ittici in base alla loro provenienza e al trattamento riservato in allevamento. L’acquacoltura sostenibile è per esempio una realtà oggi in forte espansione poiché posizionata su un versante diametralmente opposto rispetto a quello dei prodotti di scarsa qualità e caratterizzati da filiere complesse. Si tratta viceversa di prodotti di qualità certificata e che rispettano tutte le norme italiane (tra le più stringenti) ed europee in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
In questa direzione si muove il Disciplinare di produzione e la relativa identificazione con il marchio “Acquacoltura Sostenibile”, sigillo che testimonia la bontà del prodotto ittico acquistato e la sicurezza in termini di standard di produzione.
Sostenibilità ambientale, sociale ed economica
Sul fronte ambientale il pesce proveniente da acquacoltura sostenibile cresce in ambienti a norma dal punto di vista del benessere animale, a beneficio della salubrità del prodotto finale, e dell’impatto sul territorio, grazie a misure che riducono al minimo l’alterazione dello scenario naturale.
Dal punto di vista sociale rafforzare le realtà virtuose di acquacoltura sostenibile permette di agevolare i criteri di valorizzazione dei lavoratori, di assunzione di giovani e di collaborazione con il mondo della ricerca/università.
Infine, sul versante economico, la sostenibilità del mercato ittico d’allevamento colloca la filiera in un binario corretto dal punto di vista del riconoscimento del giusto prezzo in rapporto alla qualità dei prodotti proposti, generando una forma di tutela e consapevolezza maggiore per i consumatori.
Il marchio Acquacoltura Sostenibile rispetta queste tre direttrici di sostenibilità, ma non è obbligatorio. I consumatori possono però avvicinarsi ai suoi contenuti approfondendo il tema e consultando le regole del Disciplinare di produzione riconosciuto a livello europeo che determina il rilascio della certificazione. L’Italia, attraverso numerose iniziative, è in prima linea in Europa nel proporre questo standard a tutti gli operatori economici del settore.
Maggiori informazioni su www.hellofish.it.