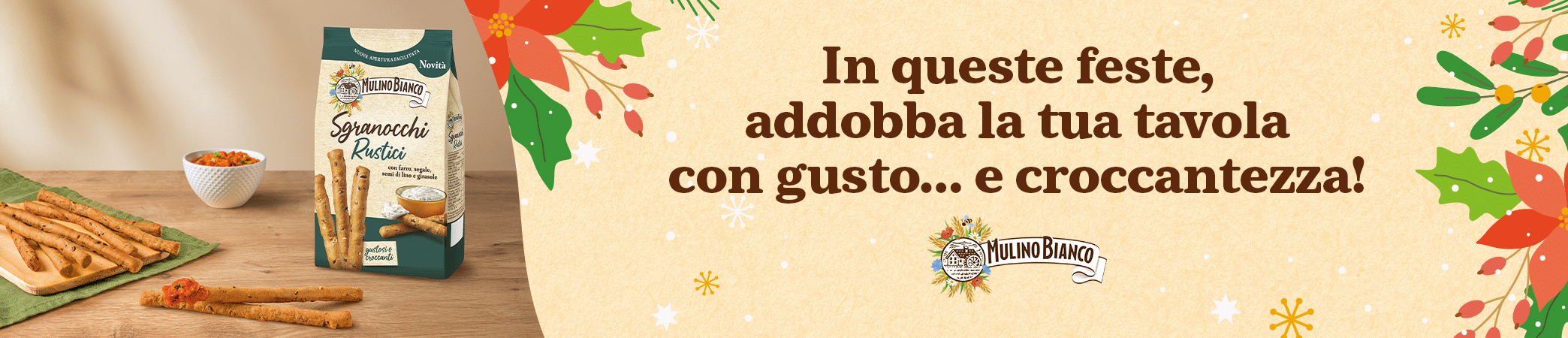Lavoratori schiavizzati, paghe da fame, procedure illegali. Dietro la produzione di gamberetti thailandesi venduti in Nord America, Europa e Giappone c’è tutto questo, e per di più si tratta di una condizione di sfruttamento che va avanti da anni. A denunciarlo è l’Associated Press che ha pubblicato un rapporto in cui sostiene che “I principali mercati di tutto il mondo non stanno facendo un buon lavoro per mantenere i gamberi sgusciati lavorati da schiavi moderni fuori dal loro sistema alimentare”, come riassume il Washington Post che ha rilanciato la notizia.
Migliaia di lavoratori in schiavitù
Grazie all’indagine di Ap sono stati liberati migliaia di pescatori schiavizzati, arrestate decine di persone e sequestrati milioni di dollari. Gli autori dell’inchiesta puntano il dito contro gli Stati Uniti, e la scarsa efficienza dei controlli alle dogane, oltre alla facilità di penetrazione dei prodotti in questione nelle maggiori catene di distribuzioni americane: Wal-Mart, Kroger, Whole Foods, Dollar General e Petco, insieme a ristoranti come Red Lobster e Olive Garden. Gli stessi gamberetti sono entrani nelle catene di approvvigionamento di alcuni dei marchi americani più conosciuti di pesce e alimenti per animali domestici.
Un grande affare
I reporter di Ap hanno scoperto i gamberetti frutto del lavoro schiavile nei supermercati di tutti i 50 stati Usa.La notizia acquista particolare gravità in virtù del fatto che solo un anno fa un’inchiesta del Guardian aveva denunciato, dopo sei mesi di ricerca, lo stesso scandalo confermato poi dal rapporto di Ap. “Se si acquista gamberi o gamberetti dalla Thailandia, inevitabilmente si acquista un prodotto del lavoro degli schiavi”, aveva commentato col Guardian, Aidan McQuade, direttore di Anti-Slavery International. Gli Usa, come altri paesi, importano almeno la metà dei gamberetti per il loro mercato dalla Thailandia. Nel 2013, invece, il rapporto della Ong Environmental Justice Foundation, arrivava alle stesse conclusioni.
E in Italia?
Probabilmente i gamberetti thailandesi al centro dello scandalo sono commercializzati anche in Italia, ma la vaghezza delle indicazioni d’origine in etichetta (le zone FAO di pescaggio che indicano un’area marina, spesso a cavallo tra diversi stati), rende quasi impossibile per il consumatore essere sicuro di non rendersi complice di questa negazione massiccia di diritti dei lavorati.