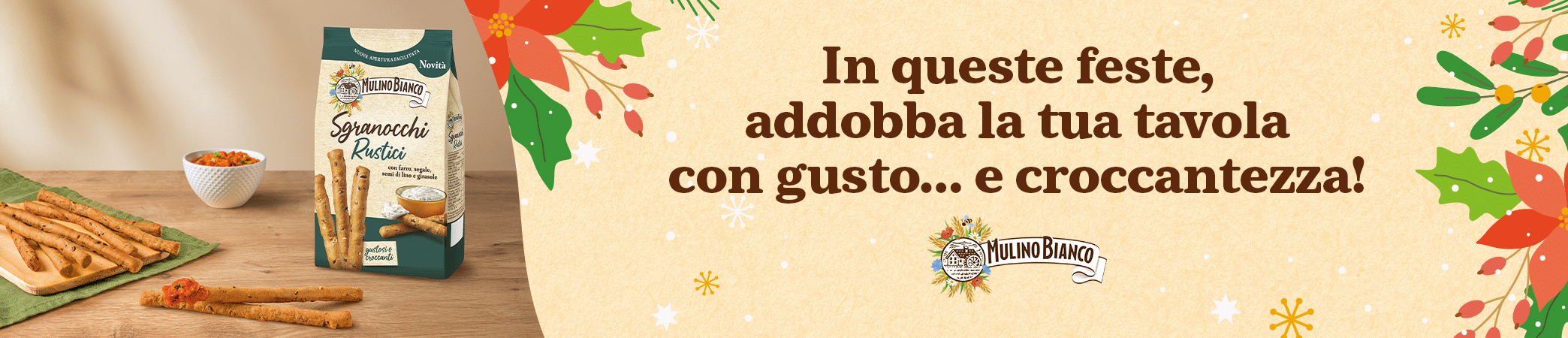Il Comune di Alessandria ha accettato il risarcimento di 100mila euro proposto dalla multinazionale Syensqo (ex Solvay) nel processo per disastro ambientale colposo da Pfas. I comitati locali e Greenpeace: “Risarcimento irrisorio, poco più di 1 euro ad abitante”
Il Comune di Alessandria ha accettato il risarcimento di 100mila euro proposto dalla multinazionale Syensqo (ex Solvay) nel processo per disastro ambientale colposo da inquinamento da Pfas attribuito al polo industriale di Spinetta Marengo. L’amministrazione ha così motivato l’accettazione della cifra: “l’unica voce a cui possono appellarsi gli enti locali è il danno di immagine”, spiegando che la decisione è arrivata: “al termine di una discussione di giunta, dopo un lungo lavoro di analisi da parte dell’avvocatura comunale e tenendo aperto un dialogo costante con i legali che tutelano i cittadini costituitisi parte civile nel processo”. Una mossa, quella della ex Solvay pensata per accorciare i tempi del processo e affievolire le pene sui reati commessi.
Le motivazioni del comune di Alessandria
Nel precedente procedimento, conclusosi alla Corte d’Assise d’Appello di Torino, il risarcimento accordato al Comune era stato di soli 50mila euro, sempre per danno d’immagine. “In questo nuovo processo – continua il Comune di Alessandria – dove i capi d’imputazione prevedono la possibilità di patteggiamento o riti alternativi che escluderebbero la costituzione di parte civile, l’offerta ricevuta è stata ritenuta congrua sulla base di tre principali criteri oggettivi. I soldi verranno utilizzati per “implementare le risorse del tavolo di monitoraggio ambientale del Comune e far fronte ai lavori straordinari che interesseranno i cimiteri cittadini“.
Greenpeace e Stop Solvay: no a patteggiamenti per pochi spiccioli
Delusione da parte di chi da anni si batte nel territorio per chiedere lo stop alla produzione di sostanze perfluoroalchiliche (diverse delle quali considerate interferenti endocrini e cancerogeni). In una nota congiunta, Greenpeace Italia, Comitato Stop Solvay e Vivere in Fraschetta, definiscono l’offerta economica, “a cifre irrisorie, financo offensive, e irrispettose dei danni provocati dall’ex Solvay, oggi Syenquo, nei confronti delle parti civili, in particolare dei singoli cittadini”. L’azienda, nell’ambito del processo in cui è chiamata a rispondere di disastro ambientale colposo presso il Tribunale di Alessandria, sta attualmente trattando con le oltre 300 parti civili (cittadine e cittadini, Associazioni, Comuni, Regione Piemonte, Ministro dell’Ambiente) che si sono costituite davanti al Giudice nel maggio 2024. “Comitati e associazioni invitano tutte le parti civili, incluse le associazioni ambientaliste e gli enti pubblici, a rifiutare le condizioni economiche proposte dall’azienda e fare in modo che sia il Tribunale di Alessandria, all’esito di un processo, ad accertare tutte le responsabilità del disastro ambientale in cui versa l’area alessandrina” scrivono le tre associazioni, che parlano di “poche migliaia di euro per i singoli cittadini, qualche centinaio di migliaia di euro per i Comuni”, mentre “alle associazioni ambientaliste costituite parti civili l’offerta scende a circa 20 mila euro, mentre alle singole persone l’importo ammonterebbe a 3500 euro, oltre a mille euro di contributo per le spese legali”. Il primo a patteggiare era stato il Comune di Montecastello per 100mila euro. Greenpeace Italia, Comitato Stop Solvay e Vivere in Fraschetta ritengono queste cifre irrispettose dei danni subiti da ambiente e salute pubblica: “Evidentemente per l’azienda il diritto alla salute e a vivere in un ambiente pulito e non contaminato hanno scarsissimo valore”.
Le accuse
Le associazioni: bloccare la produzione e bonificare
La storia di Spinetta Marengo
Spinetta Marengo è la frazione di Alessandria, dove gli scarichi industriali del vicino polo chimico ex Solvay (dal 2023 il colosso si chiama Syensq) hanno riversato nelle falde acquifere sostanze perfluoroalchiliche. Il polo chimico nasce all’inizio del Novecento, poi passato per la Montedison, fino a quando nel 2001, la Solvay lo acquisisce. La zona di Spinetta è considerata ottimale per questo tipo di produzione: ricca d’acqua sia in profondità che in superficie. Qui scorrono il Tanaro e il Bormida che confluiscono nel Po, anch’esso molto vicino, a soli 30 chilometri. L’industria chimica di base ha bisogno di attingere moltissima acqua e poi, purtroppo, di scaricare negli affluenti. Ad accompagnarci nel racconto, all’interno di “Pfas, storia di una contaminazione”, il libro che il Salvagente ha dedicato agli inquinanti per sempre è Claudio Lombardi, ingegnere in pensione, assessore all’ambiente di Alessandria fino al 2017, e membro sia del comitato che di Legambiente: “L’industria di base ha inquinato quando non c’era coscienza e norme, fino agli anni Settanta è stato un disastro, in quel periodo hanno chiuso gli impianti più inquinanti ed è partita l’industria chimica del fluoro, che è la base delle produzioni a Spinetta. Al momento dell’acquisizione da parte di Solvay, la falda era fortissimamente inquinata. Avvelenata soprattutto dal cromo esavalente, e da solventi florurati e clorurati, addirittura Ddt, arsenico, metalli pesanti”. Solvay qui produce Algoflon, un tecnopolimero simile al Teflon, usato nell’industria automobilistica, aeronautica, aerospaziale, insieme ad altri tecnopolimeri che sul mercato hanno un successo notevole: lo stabilimento di Spinetta lavora a ciclo continuo, 24 ore al giorno. “Chi acquisisce il sito deve garantire che non fuoriescano più inquinanti – spiega Lombardi – E Solvay nel 2010 crea, per ottemperare a queste richieste delle amministrazioni pubbliche, una cosiddetta barriera idraulica. Una serie di pompe aspirano l’acqua di falda con lo scopo di depurarla prima di immetterla nel condotto che convoglia tutti i reflui dello stabilimento al fiume Bormida. Questo in teoria”.
Il C6O4 disperso in ambiente
Intanto, grazie a questo progetto, Solvay ottiene l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) che gli permette di continuare a produrre. “Hanno sempre detto che la barriera funzionava, i controlli dell’Arpa facevano vedere che stavano diminuendo le sostanze inquinanti” continua Claudio Lombardi, “E si va avanti così fino al 2019, quando l’Arpa trova nell’ambiente un Pfas, il C6O4, che ha iniziato a essere prodotto all’interno della Solvay nel 2012. Dunque, ricapitolando, un inquinante che viene prodotto da loro, viene trovato al di là della barriera idraulica dove ha inquinato fortemente la falda, per poi arrivare nel Tanaro, nel Bormida, ed essere trovato nel Po in Veneto, addirittura a Porto Tolle nel delta del fiume”. Il C6O4 aveva sostituito nel 2013 il Pfoa, che per la convenzione di Stoccolma, ratificata dall’Ue, è stato messo al bando. “La razionalità vorrebbe che se sostituisci una sostanza perché tossica e inquinante con un’altra, devi fare prima delle analisi che certifichino che sia innocua. Nella chimica invece si può brevettare un prodotto, metterlo in produzione, e poi venire a sapere solo dopo se è inquinante o meno”, commenta amaro l’ingegnere Lombardi. In un parere del 2014 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare dichiara che non vi è alcun problema di sicurezza per il consumatore se la sostanza viene usata come ausiliario industriale durante la fabbricazione di fluoropolimeri. Ma nel marzo 2021, il dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione e il dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, in collaborazione con l’Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicano su Environmental International, una della più prestigiose riviste scientifiche di studi ambientali, i risultati del primo lavoro che riporta gli effetti del C6O4 sulla vongola filippina, chiamata comunemente vongola verace – esposta a questa sostanza.
I rischi per la salute
“I risultati del nostro studio dimostrano chiaramente che il C6O4 altera in modo significativo, e per alcuni versi ancora maggiore del Pfoa, i processi biologici della vongola filippina (o vongola verace) – spiega il professor Tomaso Patarnello, del Dipartimento Bca dell’Università di Padova e coordinatore della ricerca -. Questa specie, oltre a essere molto apprezzata sulle nostre tavole è un organismo chiave per l’ecosistema lagunare anche in ragione del fatto che è un organismo filtratore e quindi accumula le sostanze presenti nell’acqua. Può essere quindi considerato un organismo sentinella e le alterazioni dopo l’esposizione al C6O4 osservate nell’espressione dei geni della vongola legati a processi biologici fondamentali come la risposta immunitaria, lo sviluppo del sistema nervoso o il metabolismo lipidico sono dati molto allarmanti”. “Il fatto che questa sostanza venga usata senza nessun limite di legge assumendo che non abbia effetti sugli organismi esposti è chiaramente contraddetto dai dati sperimentali” dice il professor Massimo Milan, membro dello stesso dipartimento dell’università di Padova. Nel giugno 2020 la sostanza viene trovata vicino allo stabilimento Solvay nelle acque dei pozzi di Montecastello, dove il sindaco chiude la rete idrica in via precauzionale.
I controlli di Arpa Piemonte
Dopo i controlli ambientali di Arpa Piemonte, che avevano certificato il mancato rispetto delle emissioni di Pfas nell’ambiente, la provincia di Alessandria a inizio giugno 2024 aveva inviato a Syensqo, due diffide intimando allo stabilimento chimico di rispettare i limiti di legge consentiti per gli scarichi di queste sostanze, invitandola a rispettare negli scarichi i parametri previsti dall’Autorizzazione integrata ambientale, scesi a 0,5 microgrammi/litro sia per il C604 sia per le altre sostanza analoghe. L’azienda ha messo in campo una barriera idraulica, ma secondo Lombardi, come riporta la Stampa, “la barriera idraulica non mostra un impianto idoneo a contenere le fuoriuscite interne allo stabilimento”, e la produzione “può essere riprese solo dopo interventi risolutivi comprovati e certificati per un adeguato lasso di tempo”.
Lo stop della Provincia
Ma lo stop della Provincia di Alessandria alla produzione di C604 dura meno di un mese e mezzo. L’ingegner Claudio Lombardi spiega alla Stampa: “Lo scorso 24 luglio Solvay ha ripreso la produzione e nell’atmosfera di Spinetta, ma anche di una vasta area della Fraschetta fino a Montecastello, Piovera e Alessandria hanno ricominciato a riversarsi i tossici Pfas nell’aria”. Secondo Lombardi, “la Provincia ha autorizzato la ripresa della produzione e l’uso del cC604. Ma si apprende anche che ciò è avvenuto dopo un acceso dibattito con Arpa che aveva trasmesso relazioni comprovanti interventi risolutivi delle perdite basandosi non già su attività svolte direttamente ma su studi, controlli ed attività svolti da un perito incaricato da Solvay”. Il comitato Stop Solvay, Ànemos e Greenpeace scrivono alla Regione Piemonte dopo i risultati del monitoraggio indipendente sulla presenza nel sangue della popolazione di Spinetta Marengo dei temuti inquinanti Pfas, chiedendo di individuare prontamente i responsabili dell’inquinamento e di avviare urgentemente una bonifica.
Gli incidenti
Intanto, gli incidenti non si fermano, ad agosto 2024, alle preoccupazioni legate al ritorno della produzione di Pfas, per gli abitanti di Spinetta Marengo (Al) se ne aggiunge una nuova: dal polo ex Solvay, Syensqo, viene registrata una perdita in ambiente di acido fluoridrico. Nel pomeriggio dl 7 agosto, la fuga in aria è stata generata da uno dei reattori dell’area Algofrene, l’impianto dove vengono fatti reagire i gas per produrre i composti fluorurati, tra cui anche i Pfas. Arpa è intervenuta nel pomeriggio analizzando i dati della stazione di monitoraggio ambientale di Spinetta via Genova, dichiarando: “I dati della stazione hanno evidenziato venti provenienti dai settori nord ovest e nordest e dati di acido fluoridrico sotto i limiti di quantificazione”. dopo un secondo rilevamento, la sera stessa, Arpa ha dichiarato: “Le misure in campo effettuate con strumentazione portatile non hanno evidenziato concentrazioni significative di acido fluoridrico. È importante precisare che la pioggia ne ha favorito l’abbattimento, in quanto l’acido fluoridrico è molto solubile in acqua”. Solo uno dei tanti capitoli in una battaglia di anni che è accompagnata oggi da un processo in corso.