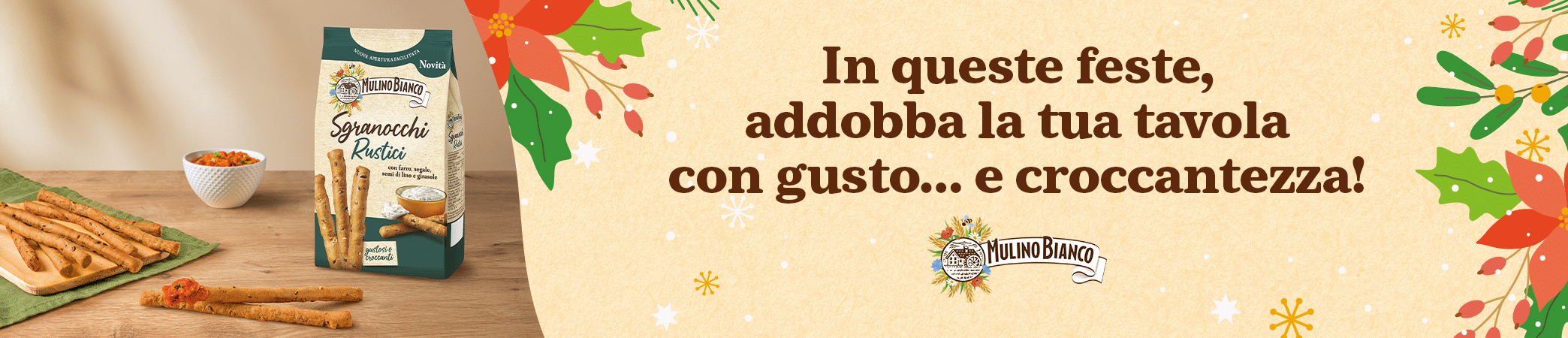Arriva dagli Stati Uniti l’ennesima puntata delle forti polemiche che in tutto il mondo girano attorno ad Uber, la società che ha spopolato grazie a un sistema per offrire passaggi a pagamento con la propria auto, via app.
La class action avviata negli Usa da 385mila autisti nei confronti dell’azienda di San Francisco si è chiusa con un accordo da 100 milioni di dollari: questa la cifra che finirà nelle tasche dei ricorrenti, che chiedevano di essere riconosciuti come “dipendenti” dell’azienda.
Uber, che della flessibilità di rapporti con gli autisti e con gli utenti ha fatto il suo punto forza, ha preferito non rischiare una sentenza sfavorevole, preferendo accettare la condizione di “freelance” di chi carica in macchina persone tramite le prenotazioni sull’app. Non si è limitata però ad aprire le casse, e ha restituito il “fastidio” agli autori della class action: in quanto freelance, infatti, il loro allontanamento dalla piattaforma diventa più facile, in caso di servizio al di sotto degli standard. Basterà un giudizio medio insufficiente da parte degli utenti per dare mano libera all’aziende che potrà liquidare il libero professionista sgradito al volante.
Non è chiaro se una sentenza del genere potrà avere ripercussioni anche in Europa e se, ad esempio, gli autisti Uber italiani proveranno a strappare un “bonus” economico seguendo strade simili.
Da Uber Italia non commentano, ma è difficile che una dinamica del genere si ripeta in Italia dove non vi è un rapporto gerarchico tra autisti e azienda: nel nostro paese, infatti, sia chi paga per un passaggio in macchina, sia chi fornisce il servizio, è tecnicamente un utente che utilizza la piattaforma per mettersi in contatto con un altro utente. Una situazione lontana da un rapporto tra dipendente e datore di lavoro, che dovrebbe lasciare il termometro della polemica alto solo per i tassisti, che non si danno pace per la “concorrenza sleale” di Uber.