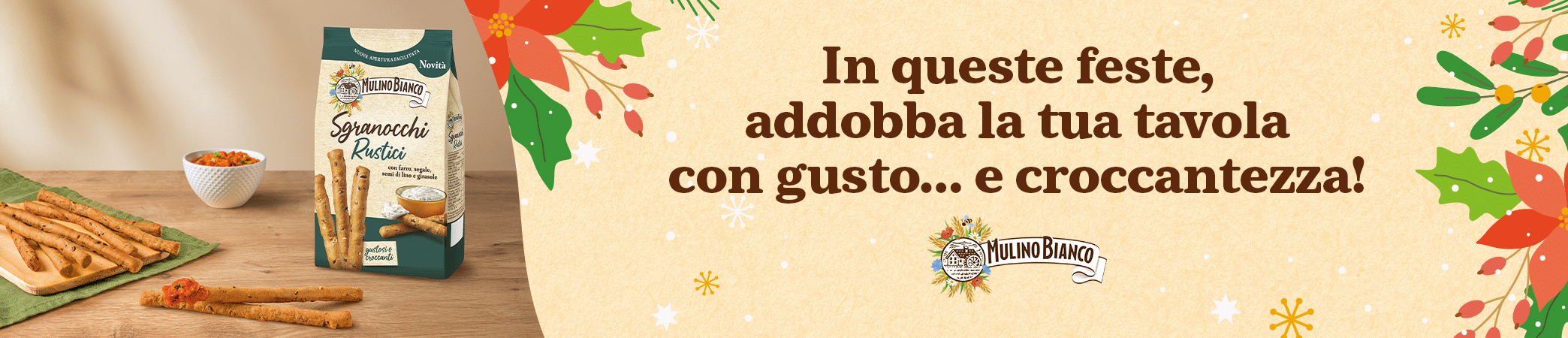250mila gli italiani hanno alti livelli di colesterolo. E la causa non è la cattiva alimentazione o uno stile di vita inadeguato ma una causa genetica che impedisce all’organismo di eliminare efficacemente dal sangue il colesterolo “cattivo”. Si tratta della cosiddetta ipercolesterolemia familiare, patologia ancora poco conosciuta, diagnosticata e trattata, tanto che si stima che in Italia abbia ricevuto una diagnosi corretta solo l’1% della popolazione che ne è affetta, mentre in Olanda si arriva al 71% delle diagnosi e in Norvegia al 43%.
All’ipercolesterolemia familiare Cittadinanzattiva, tramite le sue reti del Tribunale per i diritti del malato e del CnAMC (Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici), ha dedicato l’Indagine civica “Colesterolo, una questione di famiglia”, presentata il 26 novembre a Roma. L’indagine ha l’obiettivo di rilevare il livello di consapevolezza rispetto alla patologia e ai suoi rischi, nonché la qualità delle cure ricevute dai pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare e le criticità nella gestione quotidiana dei sintomi.
L’indagine è stata condotta attraverso questionari rivolti ai cittadini, compilati attraverso il sito internet e attraverso la somministrazione diretta: 1317 i questionari completati e validi per la rilevazione.
La conoscenza della patologia: una informazione a metà
Gli intervistati, in prevalenza donne con età compresa tra 41 e 30 anni, hanno problemi di colesterolo elevato: il 37% ha ipercolesterolemia e oltre il 27% ipercolesterolemia familiare. Il 27% soffre di ipertensione, il 9,6% di elevati livelli di trigliceridi e il 9% è obeso. Un terzo del campione identifica correttamente le dislipidemie come una malattia legata al sovrappeso; poco meno della metà (45%) riconosce l’ipercolesterolemia familiare come una elevata concentrazione di colesterolo nel sangue ma solo poco più di un terzo (34,6%) sa che è di origine genetica.
Una patologia sotto-diagnosticata
Più di un cittadino su dieci dichiara di aver avuto il primo sospetto della patologia in maniera quasi autonoma, cercando sul web, reperendo informazioni in tv o sui giornali; il 40% grazie al fatto di avere un familiare già affetto, il 29,4% è stato invece diagnosticato dal medico di famiglia; solo l’1,5% ha avuto diagnosi in età infantile grazie al pediatra di famiglia. Dopo la prima diagnosi, il 60% afferma che i familiari sono stati sottoposti agli esami diagnostici, ma c’è anche un 15% che dichiara che il proprio medico non ha ritenuto necessaria l’estensione degli stessi a tutta la famiglia.
Burocrazia, carenza di specialisti, costi, problemi nella cura
Oltre un paziente su tre afferma di aver difficoltà ad individuare uno specialista e quasi il 39% dichiara che c’è poca collaborazione tra specialista e medico di famiglia. Più di un paziente su quattro (26,5%) lamenta la carenza di reparti o centri specialistici. Una volta scovato il centro, essendo pochi, le liste d’attesa per visite ed esami specifici per il controllo della malattia sono particolarmente lunghe (12%). Il 23% di chi ha ricevuto una diagnosi resta però senza una terapia. Fra chi l’ha ricevuta, nell’83% dei casi si tratta di una terapia farmacologica. Non allo stesso modo viene, invece, prescritta la dieta (68,3%) e l’attività fisica (65,6%). Un paziente su quattro (21%) dichiara di non essere stato sottoposto a ulteriori accertamenti. Solo l’1,8% ha partecipato a corsi di formazione per la gestione della patologia.
Inoltre, il 23% dichiara di aver avuto difficoltà a monitorare la malattia, per liste di attesa troppo lunghe (45%), o perché gli esami sono a pagamento (25%). Il 15,6% lamenta il costo eccessivo della terapia farmacologica. Anche i genitori dei pazienti più piccoli segnalano un problema di costi: il 12,9% dice che l’esenzione non copre tutte le prestazioni sanitarie di cui il bambino avrebbe bisogno e il 12% dichiara che il carico assistenziale è troppo oneroso. Così, quasi uno su cinque (19%) si dice costretto a rinunciare ad alcuni esami o visite.
Rispetto, invece, alle difficoltà non prettamente cliniche, riscontriamo al primo posto la burocrazia (17%), quindi la mancanza di sostegno psicologico (8,5%) e l’impatto della malattia, sul lavoro e la vita privata (8%). Quello che emerge è che i pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare chiedono non solo un miglioramento nella qualità delle cure, ma soprattutto una migliore e più umana gestione della patologia, affinché, come scrive uno degli intervistati “…il malato innanzitutto non debba sentirsi tale”.
La prevenzione privata
Altra nota dolente è la prevenzione: un intervistato su due dichiara di riscontrare difficoltà nello svolgere una regolare attività fisica, circa il 42% a seguire una corretta alimentazione ed il 18,2% ad abbandonare la cattiva abitudine del fumo. Cambiare lo stile di vita poco salutare non è facile, a causa dell’abitudine ad una vita sedentaria (24,8%) ma anche perché l’attività a pagamento è costosa (20,7%), perché mangiare sano è faticoso ( 24%). La prevenzione è lasciata alla “buona volontà” del singolo individuo e non incentivata né sotto il profilo formativo ed informativo, né sotto il profilo economico, né tantomeno quello psicologico.
Le proposte di Cittadinanzattiva
Promuovere attività di informazione e formazione rivolte prioritariamente ai professionisti sanitari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in primis, ed alla popolazione in generale sull’ipercolesterolemia familiare, per arrivare ad una diagnosi precoce e sfatare falsi miti come ad esempio che il colesterolo è sempre solo un problema di stile di vita e/o dieta. L’informazione deve diventare ancora più trasparente e precisa quando la persona riceve una diagnosi di ipercolesterolemia familiare: dalle indicazioni sui centri e sugli specialisti di riferimento, alle modalità di prenotazione e tempi di attesa. Inoltre l’investimento sull’empowerment e sul self management della persona malata e/o dei familiari deve essere potenziato per favorire la migliore qualità di vita e autonomia possibile.
Promuovere e costruire un Percorso Diagnostico-terapeutico assistenziale di riferimento nazionale che garantisca diagnosi precoce, continuità assistenziale, presa in carico, prevenzione delle complicazione e riduzione della variabilità clinica. Il PDTA, basandosi sulla medicina delle evidenze (EBM) deve partire dai bisogni di pazienti, evitando tutti i disagi finora vissuti da chi è affetto dalla patologia come ad esempio la dislocazione/raggiungibilità dei centri, burocrazia, tempi di attesa, etc., assicurando l’accompagnamento e la presa in carico. Tra i punti di partenza le buone pratiche nazionali e internazionali. Per questo Cittadinanzattiva chiede alle istituzioni competenti di valutare l’opportunità di promuovere programmi di screening organizzato sulla popolazione a rischio, analizzando modelli internazionali in essere come ad esempio l’Olanda, sulla base della EBM e dell’applicazione di un rigoroso processo di Health Technology Assessment che veda il coinvolgimento, tra gli altri, di professionisti e società scientifiche, bio-eticisti, associazioni di cittadini e pazienti.
Garantire un investimento in prevenzione, in particolare quella primaria. Incentivare fin dalla prima infanzia campagne di promozione ed educazione ai corretti stili di vita, vigilando sull’alimentazione, in particolare scolastica. Incentivare l’attività fisica (gruppi di cammino, agevolazioni fiscali, convenzioni per persone con patologie croniche e rare). Intervenire con disposizioni specifiche come la tassazione del junk food, ossia del cibo spazzatura, come accade in altri paesi d’Europa.