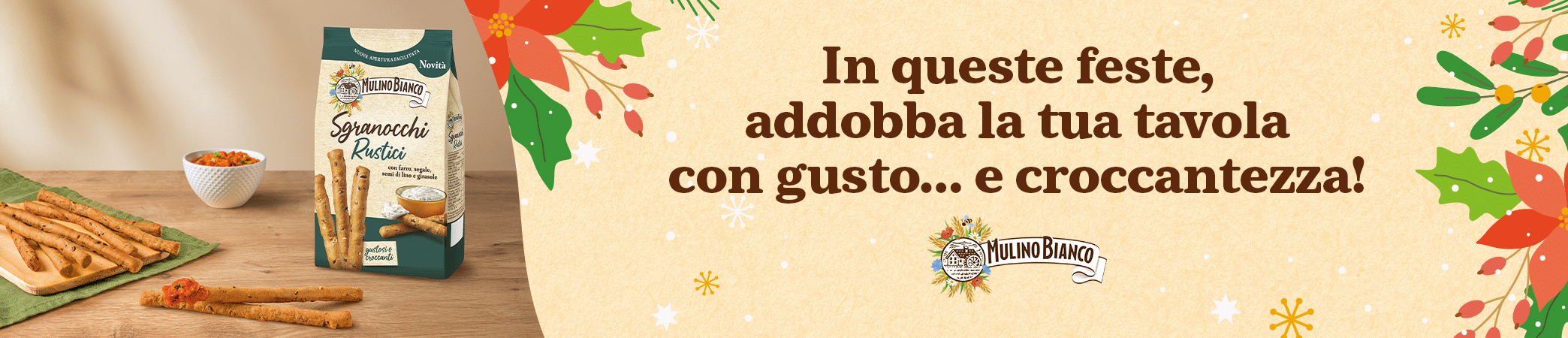Le isole di plastica sono ormai una costante negli oceani ma ce n’è una anche nel Mar Mediterraneo che sarebbe persino più densa della più nota “spazzatura” galleggiante al largo del Pacifico. Cosa fare per evitare questo disastro
Suonano oggi profetiche le considerazioni del saggista e semiologo francese Roland Barthes quando sosteneva che “il mondo intero può essere plastificato, e perfino la vita”. Il chimico inglese Alexander Parkes non poteva certo prevedere gli effetti nel lungo tempo della sua invenzione, quando, tra il 1861 e il 1862, isola e brevetta il primo materiale plastico semisintetico, che battezza inizialmente Parkesine e che si diffonde poi come Xylonite. Ma è dagli anni 50 del Novecento che con l’invenzione del moplen ad opera dell’ingegnere italiano Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963), che la plastica trova diffusione planetaria e irrompe nella vita quotidiana di tutti.
Una produzione sempre più crescente e quasi inarrestabile di plastica dal dopoguerra in poi. Una corsa che si arresta solo nel 1973, l’anno della grande crisi petrolifera innescata dalla guerra dello Yom Kippur, e poi nel 2008, la crisi finanziaria cominciata e la grande recessione economica, la peggiore dal dopoguerra, e poi ancora durante il primo anno di pandemia. Secondo i dati di PlasticsEurope, la produzione mondiale di plastica si è fermata a 367 milioni di tonnellate, la cifra più bassa dal 2008, con un calo del 5,1%.
Questi dati sono il sintomo che la produzione e il consumo di plastica sono strettamente legati a un sistema economico estremamente consumistico e poco eco-sostenibile. Infatti, ogni volta che scoppia una crisi economica, la produzione si arresta. L’ultimo calo, tuttavia, può essere l’inizio di un definitivo ma lento processo di cambio di rotta; il report PlasticsEurope stima più investimenti a favore del riciclo chimico, essenziale nell’ottica di una transizione verso un’economia circolare, perciò si dovrebbe passare dai 2,6 miliardi di euro del 2025 ai 7,2 miliardi del 2030.
Intanto la plastica pervade ovunque, grazie alla sua economicità, diffusione, utilizzo capillare in vari settori di attività e persistenza nel tempo. Nel frattempo, il pianeta continua a soffrire anche a causa dell’inquinamento da plastica, che consiste nella dispersione e nell’accumulo di materie plastiche nell’ambiente, alimentando problemi all’habitat di fauna e flora selvatica, oltre che a quello umano. Tale tipo di inquinamento può interessare l’aria, il suolo, i fiumi, i laghi e gli oceani.
Il nemico quasi invisibile
La plastica può essere un nemico subdolo e quasi invisibile. Nel 2017 è stato presentato un rapporto redatto con analisi in tutto il mondo, sulla presenza di microparticelle di plastica nelle acque e nell’aria, che per le loro ridotte dimensioni entrano nelle catene alimentari. Le microparticelle sono prodotte col lavaggio degli indumenti sintetici, con l’usura di pneumatici, col deterioramento delle vernici, con il lavaggio di prodotti estetici, fino agli alimentari come testimonia il test condotto dal Salvagente nell’ottobre 2018.
Con microplastica, dunque, ci si riferisce a piccole particelle di materiale plastico generalmente più piccole di un millimetro fino a livello micrometrico. E l’inquinamento da microplastiche causato da rifiuti di piccolissime dimensioni che si infiltrano nell’ambiente e negli alimenti è ritenuto una minaccia per l’ecosistema e la salute umana.
Dove finiscono queste microplastiche?
Trasportate dai fiumi, plastiche e microplastiche finiscono nei mari e negli oceani. A partire dagli anni 90 del Novecento è stato identificato un ammasso di rifiuti galleggianti costituiti prevalentemente da frammenti plastici di dimensioni inferiori ai 5 millimetri. Si tratta di una isola di plastica molto estesa le cui misure non sono ancora definite: le stime vanno da 700mila km² fino a più di 10 milioni di km² (cioè da un’area più grande quanto la Spagna a un territorio persino più esteso della superficie degli Stati Uniti), ovvero tra lo 0,41% e il 5,6% dell’Oceano Pacifico. Questa isola di plastica è stata ribattezzata Pacific trash vortex (ma anche great Pacific garbage patch, in italiano “grande chiazza di immondizia” del Pacifico, o isola di rifiuti plastici).
L’Algalita Marine Research Foundation e la Marina degli Stati Uniti stimano l’ammontare complessivo della sola plastica in quest’area in un totale di 3 milioni di tonnellate. L’oceanografo americano Charles Moore ritiene che l’area potrebbe contenere fino a 100 milioni di tonnellate di detriti.
La plastica invade anche il Mediterraneo
Purtroppo questi “patch” stanno diventando una triste lista che si sospetta sia più lunga di quanto si pensi. Nick Mallos, direttore del programma Trash Free Seas presso l’Ocean Conservancy, organizzazione no profit per la tutela degli oceani, sostiene che “la plastica ormai è ovunque nel mondo, in tutto l’ecosistema marino e nell’intera catena alimentare, dagli uccelli marini e le tartarughe marine alle foche. È un problema davvero globale che si alimenta su larga scala, e di cui vediamo gli effetti aumentare sempre di più”.
E infatti l’inquinamento causato dalla plastica non colpisce soltanto gli oceani Pacifico e Atlantico, ma anche il nostro Mar Mediterraneo. A Nord Ovest dell’isola d’Elba, tra il corno della Corsica e la Capraia, è apparsa un’isola di rifiuti di plastica composta da frammenti più piccoli di 2 millimetri. Un’isola di microplastiche che secondo alcuni analisti potrebbe essere il doppio più densa di quella del Pacifico, spinta dalle correnti e dall’idrodinamica di questo bacino semichiuso del Mediterraneo, dove questi materiali inquinanti tendono a concentrarsi in un’area certamente più piccola (si stima di qualche decina di chilometri) ma in forte espansione.
Questa isola di plastica del Mediterraneo sarebbe l’accumulo di rifiuti che deriverebbero dai grandi fiumi che sfociano nel Tirreno come l’Arno, il Tevere ed il Sarno.
Il Wwf (l’organizzazione non governativa World Wide Fund for Nature) sostiene che nel Mar Mediterraneo siano già presenti oltre 570 mila tonnellate di rifiuti plastici.
Un capodoglio “gravido” di plastica
Nel luglio 2020 sulla rivista National Geographic è stato documentato il caso della femmina di capodoglio incinta e morta con 23 chili di plastica nello stomaco. È accaduto a pochi passa da una spiaggia fuori Porto Cervo, in Sardegna.
“L’inquinamento da plastica – scriveva la giornalista Alejandra Borunda – è penetrato anche nelle più profonde fenditure dei mari e il Mar Mediterraneo non fa eccezione. Raccoglie rifiuti dai paesi bagnati dalle sue acque, e siccome è un mare chiuso, i rifiuti rimangono bloccati nelle sue acque, praticamente per sempre. In un recente rapporto, Greenpeace ha stimato che la maggior parte dei grandi rifiuti di plastica che finiscono nei corsi d’acqua europei – da 150.000 a 500.000 tonnellate ogni anno – si riversano nel Mediterraneo”.
“Non ho mai visto una tale quantità di plastica” – affermava Luca Bittau, biologo marino della Seame Sardinia, organizzazione no profit dedita allo studio e alla protezione dei cetacei che popolano la regione. Hanno trovato reti e fili da pesca, buste di plastica, alcune così recenti che il codice a barre era ancora leggibile, tubi di plastica, e persino piatti usa e getta, come quelli che utilizziamo nelle nostre case. “È stato come vedere la nostra vita di tutti i giorni, ma dentro il suo stomaco”, era il commento tragico di Bittau, al ritrovamento del cetaceo.
Una chiazza di detriti galleggianti simile, con densità comparabili, è presente anche nell’Oceano Atlantico (è chiamata “North Atlantic garbage patch“). Molti animali come tartarughe e uccelli muoiono a causa dell’inquinamento da plastica, soprattutto a causa della sua ingestione che può provocare occlusioni o perforamento dell’apparato digestivo.
Le plastiche alogene rilasciano sostanze chimiche nocive al terreno circostante, che penetrano in profondità raggiungendo falde acquifere o altre fonti d’acqua. I danni sono molto seri per le specie viventi che assumono questa acqua inquinata.
Da dove provengono le isole di plastica?
Si suppone che l’80% dei detriti provenga da terraferma attraverso i fiumi. Nel caso dell’Oceano Pacifico, l’accumulo potrebbe essersi formato a partire dagli anni 80 del Novecento, a causa dell’incessante inquinamento da parte dell’uomo e dall’azione della corrente oceanica chiamata Vortice subtropicale del Nord Pacifico (North Pacific Subtropical Gyre), dotata di un particolare movimento a spirale in senso orario. Il centro di tale vortice è una regione relativamente stazionaria dell’Oceano Pacifico (ci si riferisce spesso a quest’area come la latitudine dei cavalli), che permette ai rifiuti galleggianti di aggregarsi fra di loro nei primi strati della superficie oceanica.
Ma i rifiuti che confluiscono dai fiumi non sono l’unica “fonte”. Anche le improvvise tempeste provocano la caduta di interi container trasportati da navi cargo, il cui contenuto va non solo ad alimentare il North Pacific Gyre, ma va anche ad arenarsi su spiagge poste ai confini del PTV. La più famosa perdita di carico è avvenuta nel 1990, quando dalla nave Hansa Carrier sono caduti in mare ben 80mila articoli, tra stivali e scarpe da ginnastica della Nike che, nei tre anni successivi, si sono arenati nelle spiagge degli stati della British Columbia, Washington, Oregon e Hawaii. Nel 1992 sono caduti in mare decine di migliaia di giocattoli da vasca da bagno, mentre nel 1994 è stata la volta di attrezzature per hockey su ghiaccio. Questi eventi notevoli sono molto utili per determinare, da parte delle diverse istituzioni interessate, i flussi delle correnti oceaniche su scala globale.
Il Terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011 ha colpito la costa orientale giapponese l’11 marzo e ha provocato un enorme afflusso di detriti nell’oceano. Questi rifiuti, galleggiando, sono stati spinti dalle correnti e si sono distribuiti nell’oceano Pacifico, raggiungendo anche la costa americana. Uno studio condotto nel luglio 2012 ha rivelato che parte dei detriti galleggianti si sono accumulati nel Pacific Trash Vortex accrescendolo fino ad una larghezza di 2.000 miglia, dei quali solo il 2% non è costituito da plastica.
Strani oggetti neri nell’isola di plastica del Pacifico
Glen Kissack, operation manager del progetto The Ocean Cleanup, ha svelato il “mistero” degli strani oggetti neri rinvenuti nell’isola di plastica del Pacifico. Si tratta di una specie di trappole per anguille, utilizzate dai pescatori per catturare le missine. Nome scientifico Myxine glutinosa, la missina è un invertebrato simile all’anguilla molto diffuso nelle acque dell’Oceano Atlantico nord-orientale ma che spesso si trova anche nei mari italiani. Poi i pesci catturati vengono venduti sul mercato coreano e vengono utilizzati per produrre abbigliamento e accessori con la loro pelle. Una volta catturata la missina, i pescatori ributtano in mare la parte della trappola non più riutilizzabile. Aumentando, così, la loro presenza nelle acque dell’Oceano.
Le iniziative nel mondo
Intanto, si moltiplicano le iniziative nel mondo, sia di sensibilizzazione al tema che di messa a punto di progetti tecnologici in grado di “aspirare” questi rifiuti galleggianti.
Il 26 Giugno 2020 in Italia è stata inaugurata Moby Litter, la balena di ferro che mangerà simbolicamente 4 metri cubi di rifiuti di plastica marini ad Ancona. Servirà per raccogliere i rifiuti plastici delle spiagge della Regione, grazie alla partecipazione degli studenti di 14 istituti superiori della zona.
The Ocean Cleanup è un progetto nato dall’idea del giovane olandese Boyan Slat, utilizzato per la Great Pacific Garbage Patch dove sono stati eliminati ben 103 tonnellate di rifiuti dal Pacifico Settentrionale con una mega operazione di pulizia la prima settimana di luglio 2020.
Ancora prima, nel 2009, è stata lanciata una operazione nell’ambito del progetto Kaise, dell’associazione Ocean Voyages Institute. Per l’occasione, una nave Kwai durante una spedizione di 48 giorni ha rimosso 103 tonnellate di rifiuti in plastica, conferiti poi in centri di raccolta e riciclo.
Mary Crowley, fondatrice e direttrice dell’Ocean Voyages Institute afferma che particolarmente grave è il problema delle reti da pesca alla deriva. L’istituto porta avanti uno studio dal 2018 seguendo la “Teoria di Crowley”, secondo la quale, le correnti oceaniche orientano i detriti in maniera tale che una rete da pesca, geolocalizzata con GPS, possa portare ad altre reti alla deriva.
Anche le industrie e le case di moda si stanno mostrando fortemente sensibili al tema. Qualche giorno fa, giugno 2022, il marchio del tessile streetwear Blowhammer ha lanciato una raccolta fondi volta al raggiungimento di 2 milioni di euro, con l’obiettivo di perseguire strategie innovative, attente all’ambiente e alle tecnologie digitali. “Avete presente il Pacific trash vortex, l’immensa isola d’immondizia che galleggia sull’Oceano Pacifico? Ecco, Blowhammer lì dentro non c’è!”, ha dichiarato Salvatore Sinigaglia, founder e ceo Blowhammer.
Lodevole anche l’iniziativa di Coop e Lifegate che hanno posizionato nel tempo diversi Seabin, il cestino “acchiappa plastica”, in tratti marini e lacustri italiani.
L’isola di riifiuti del Pacifico si sta ripopolando..
Giungono notizie di un ripopolamento di altre specie nel “vortex” del Pacifico. Si parla soprattutto di anemoni, di piccoli crostacei, di molluschi e di idrozoi, che vivono stabilmente su questo substrato di rifiuti galleggianti, spinti lì dopo il disastro nucleare di Fukushima del 2011. Ben dieci anni dopo, Bruxelles ha stabilito che non sarà più possibile immettere sui mercati degli Stati membri dell’Unione europea piatti, posate, cannucce, aste per palloncini e bastoncini cotonati di plastica monouso. La strada è ancora lunga e tra qualche decennio, il rischio che si corre è che in mare ci siano più plastiche che pesci.