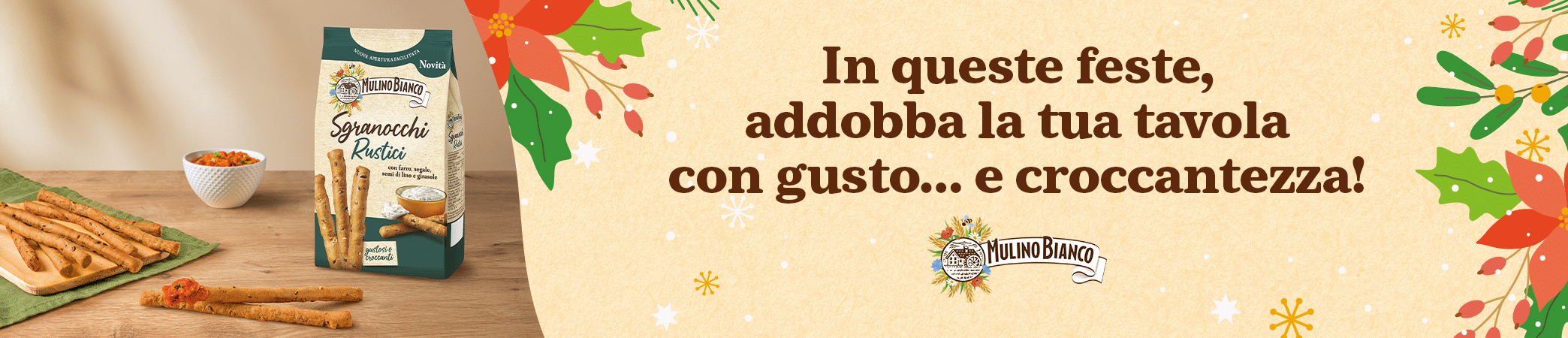O meglio, dovrebbe essere sufficiente un logo rilasciato dal ministero dell’Ambiente, il Made Green in Italy. Tra prosciutti, tubi in polietilene, shopper in plastica che lo hanno ottenuto, però, si fatica a distinguerlo dal marketing. L’approfondimento nel numero in edicola
Cosa ci fanno nello stesso elenco un prosciutto, tubi in polietilene, servizi di lavaggio di abiti ospedalieri, forniture di kit chirurgici, un formaggio, shopper in plastica e tre bottiglie d’olio di diversi formati? Non si tratta dello strano bagaglio per una scampagnata ma dell’elenco di prodotti e servizi che il nostro ministero dell’Ambiente definisce “Made Green in Italy”, a cui dedichiamo un approfondimento nel numero in edicola.
La certificazione ministeriale, entrata in vigore nel 2018, raffigurata dal bollino sopra nella foto, serve a garantire che il bene o il servizio fornito è stato prodotto seguendo stringenti norme di risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente. Ma la stessa certificazione pone una serie di interrogativi che ritornano a galla dopo che lo scorso 3 febbraio 2025 è scaduto il terzo bando promosso da ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione di “Regole di categoria di prodotto (Rcp)”, necessarie ad ottenere, appunto, il bollino “Made Green in Italy”. Il bando serve a finanziare soggetti pubblici o privati, tra cui piccole e medie imprese, che dovranno preparare regolamenti per valutare l’impronta ambientale dei prodotti delle aziende che richiedono la certificazione.
Un made in Italy “allargato”
Lo “schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti”, secondo il ministero “ha l’obiettivo di valorizzare sul mercato i prodotti italiani con buone/ottime prestazioni ambientali”. Ai prodotti riconosciuti come tali può essere apposto il marchio della certificazione: il logo del ministero dell’Ambiente arricchito dalla scritta “Made Green in Italy”.
Le valutazioni sono effettuate con una specifica metodologia europea, la Product environmental footprint (Pef), che stabilisce l’impronta ecologica di un prodotto in tutte le fasi della sua realizzazione. Per ottenere la certificazione di un prodotto serve che esistano e siano rispettate le Rcp relative. Per elaborarle negli ultimi anni ci sono stati tre bandi. Il primo nel 2018, con lo stanziamento di 400mila euro complessivi; il secondo nel 2022, con 410mila euro; il terzo, pubblicato lo scorso gennaio, ha messo a disposizione 114mila euro.
A richiedere la certificazione sono le aziende, che possono ottenere un rilascio a tempo del bollino. Quello che desta perplessità è che possono essere candidati servizi o prodotti di qualunque categoria: c’è anche un prosciutto preaffettato in vaschetta in plastica. Se sembra un espediente che ha poco oltre all’evidente utilità pubblicitaria, è perché ci sono tutte le condizioni perché sia così. Lo stesso sito ministeriale parla di “una assoluta novità nello scenario della certificazione ambientale a disposizione delle strategie di marketing aziendale” e uno strumento “a cavallo tra la politica ambientale e il marketing aziendale”. La certificazione, si legge sul sito, è “l’unica in grado di coniugare la dimensione delle performance ambientali dei prodotti, in tutta la loro catena del valore, con la dimensione del made in Italy, legata alle eccellenze del sistema produttivo nazionale”. In realtà però su questo aspetto – e su diversi altri – ci sono diversi dubbi.
Come spiega Antonino Morabito, responsabile fauna e benessere animale di Legambiente: “La certificazione, anche se sottolinea la componente made in Italy, può riferirsi anche a prodotti che non lo sono al 100% e ma che hanno parte del processo di lavorazione in altri paesi”. E in effetti lo stesso ministero specifica: “Un prodotto che non è 100% made in Italy e coinvolge altri paesi nella sua lavorazione può comunque aderire allo schema, se l’ultima sostanziale trasformazione, economicamente giustificata, avviene in Italia”. Come suggerisce Morabito, la prima cosa da chiarire è se abbia senso “dire che un prodotto è italiano, se in Italia viene compiuta solo l’ultima fase della sua lavorazione”. Il problema non è di difesa delle produzioni nazionali tout court ma sostanziale: “Se guardiamo alla filiera alimentare, vediamo che gran parte dei prodotti provengono da altri paesi in cui hanno enormi impatti ambientali come la deforestazione. Ci sono poi i costi ambientali del trasporto animale, soprattutto per i prodotti che hanno domanda così elevata per cui non basterebbe la produzione interna”. La certificazione inoltre non tiene in considerazione gli impatti sociali delle produzioni o il rispetto dei diritti umani di chi lavora. “Quando chiediamo attenzione al cambiamento climatico – spiega Morabito – lo facciamo anche perché c’è una parte importante della popolazione mondiale che ne paga le conseguenze sociali, di salute, di lavoro. Sono elementi che vanno considerati insieme, non si può definire sostenibile qualcosa che lo è, forse, solo in parte”.
Il bollino non lascia l’impronta
La certificazione, benché lanciata nel 2018, oggi è applicata a soli 68 prodotti, appartenenti a categorie merceologiche o di servizi imparagonabili tra loro. Ci sono il noleggio o lavaggio di kit chirurgici, di abiti medici o ospedalieri, di tenute da lavoro, di tessili per utilizzi ospedalieri, alberghieri o turistici. Ci sono tubazioni in polietilene per acqua sanitaria, fognature o usi industriali, acque potabili o gas. Ci sono getti in acciaio di diverse tipologie (il getto è il prodotto finale di un processo di fusione e colata di un metallo), ci sono 8 diversi tipi di shopper in plastica, prodotti tutti dalla stessa ditta ma di modelli e dimensioni diverse. Ci sono otto tessuti sintetici. E poi i prodotti alimentari: un Asiago del caseificio Casona; uno specifico Prosciutto di Parma nelle variabili disossata, con osso e preaffettato in vaschetta Devodier, e due diversi marchi di olio d’oliva dell’Oleificio Zucchi.
Se la domanda della certificazione in questi 8 anni è stata bassa, la stessa scarsa attenzione l’hanno avuta i processi di consultazione pubblica aperti per i regolamenti di categoria di prodotto. Dal 2019 sono state molto pochi. In tredici casi non è stato ricevuto nessun contributo, mentre nella maggior parte delle volte – sedici – c’è stato un unico intervento, da parte dell’Università Sant’Anna di Pisa, che però è consulente tecnica del ministero. In altre, sporadiche, occasioni, ci sono stati interventi di altri attori: il dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II, e altre 10 tra associazioni di categoria, imprese e imprese sociali. In ogni caso per le diverse proposte in consultazione ci sono stati al massimo due contributi, in un unico caso si è arrivati a quattro. Per essere uno strumento di partecipazione, si tratta di numeri davvero bassi.
Ma c’è un limite alla base di questa certificazione: il suo ambito di applicazione. Risulta ambiguo certificare allo stesso modo prodotti molto diversi tra loro. Ci torna in aiuto a tal proposito, citare un derivato animale: “Tra i prodotti approvati – ha riportato Morabito – c’è anche un prosciutto. Magari è realizzato con un metodo di produzione realmente sostenibile, ma di certo non è più sostenibile di un prodotto vegetale”. In generale “ci sono diversi problemi nel metodo di valutazione utilizzato legati al fatto che ormai si usa ovunque il termine sostenibilità, come se fosse una categoria assoluta”.
È così che possono essere definiti sostenibili addirittura gli shopper in plastica. In generale non sembra essere lo strumento in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini quando scelgono un prodotto che ritengono “sostenibile”. “Un consumatore – riflette Morabito – quando legge un’etichetta deve avere chiaro qual è il suo significato. Se leggo Made Green in Italy mi aspetto che un prodotto sia completamente sostenibile e completamente di origine italiana. Se scopro che non lo è, smetterò di credere in generale al sistema di etichettatura, perché ne è minata la mia fiducia. Se non lo scopro, la situazione è anche peggiore perché vuol dire che sono stato ingannato. A maggior ragione se parliamo di un marchio istituzionale, con il logo del ministero”.